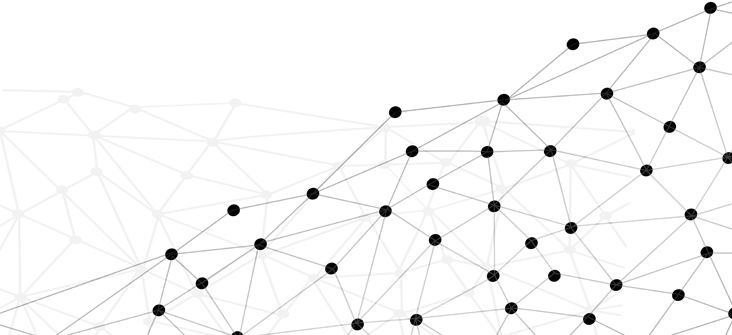EN
IT
Programma
PRIMA SETTIMANA:
1. ll metodo negli studi di diritto; nozione di diritto
2. Due famiglie di sistemi giuridici: common law e civil law
3. Origini e caratteristiche dello stato moderno
SECONDA SETTIMANA:
1. Diritto pubblico nazionale e internazionale
2. Fonti del diritto
3. Federalismo e regionalismo
TERZA SETTIMANA:
1. Rapporti tra ordinamenti giuridici: a) l'ordinamento giuridico dell'Unione europea
2. Rapporti tra ordinamenti giuridici: b) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
3. Rapporti tra ordinamenti giuridici: c) l'arena globale
QUARTA SETTIMANA:
1. (segue) Rapporti tra ordinamenti giuridici: d) schemi transnazionali
2. Diritto pubblico e potere politico: forme di governo - separazione dei poteri
3. Diritto pubblico e potere politico: lo stato costituzionale
QUINTA SETTIMANA:
1. Il ruolo del potere giudiziario: modelli di controllo costituzionale della legislazione
2. Il ruolo del potere giudiziario: la giustizia nell'amministrazione - stato di diritto
3. Il ruolo del potere giudiziario: la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà (I)
SESTA SETTIMANA:
1. (segue) Diritti fondamentali e libertà (II): proporzionalità e bilanciamento
2. Diritto amministrativo e agenzie amministrative: a) principio di legalità
3. Diritto amministrativo e agenzie amministrative: b) procedimenti amministrativi; lo Stato regolatore
Program
1. Issues of methods in legal studies; concept of law
2. Two families of Legal Systems: Civil Law and Common Law
3. Origins and features of the modern Nation-State
WEEK TWO:
1. Domestic and International Public Law
2. Sources of Law
3. Federalism and regionalism
WEEK THREE:
1. Legal orders relationships: a) the European Union legal system
2. Legal orders relationships: b) the European Convention of Human Rights
3. Legal orders relationships: c) the Global arena
WEEK FOUR:
1. (cont'd:) Legal orders relationships: d) transnational patterns
2. Public law and political power: forms of government – separation of powers
3. Public law and political power: the Constitutional State
WEEK FIVE:
1. The role of the judiciary: patterns of constitutional review of the legislation
2. The role of the judiciary:
3. The role of the judiciary: protection of fundamental rights and freedoms (I)
WEEK SIX:
1. (cont'd) Protection of fundamental rights and freedoms (II): proportionality and balancing
2. Administrative law and administrative agencies: a) rule of law
3. Administrative law and administrative agencies: b) administrative proceedings; the regulatory State
Testi Adottati
1. Textbook: Andrea Buratti, Western Constitutionalism, 3rd edition, Giappichelli-Springer, 2023, ISBN 9791221101683
2. Casi e materiali discussi in classe, caricati sul sito web del corso e elencati ogni anno nel Sillabo
Books
1. Textbook: Andrea Buratti, Western Constitutionalism, 3rd edition, Giappichelli-Springer, 2023, ISBN 9791221101683
2. Required materials and readings as discussed in class, uploaded in the course's website and as pointed out in the annual Syllabus
Bibliografia
Masterman - Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019
M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford University Press, 2010
Bibliography
Masterman - Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019
M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford University Press, 2010
Modalità di svolgimento
36 ore, ripartite in 18 lezioni di 2 ore ciascuna, nel primo semestre, tre volte a settimana.
Discussione frontale, analisi di casi pratici e normnativa e dibattito con gli studenti
Teaching methods
36 hours divided into 18 classes, two hours' each, during the first semester, thrice a week.
Lectures, presentation of cases and materials and debate in class.
Regolamento Esame
I risultati dell'apprendimento sono valutati attraverso una prova scritta (50% ) e un esame finale orale (50% ), il cui peso è equivalente; la votazione finale è il frutto della loro media. La prova scritta consiste in un test di 30 domande a risposte chiuse (4 risposte per ogni domanda), un punto per ogni risposta esatta, nessuna penalizzazione per risposte erronee. Punteggio minimo di sufficienza è 18/30.
Gli studenti che hanno superato l'esame scritto potranno sostenere l'orale contestualmente oppure in altro appello nella stessa sessione di esami.
Di seguito i criteri per l'attribuzione del punteggio orale:
o 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
o 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
o 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
o 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
o 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità
di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo
originale.
Exam Rules
Learning outcomes are assessed through a written test (50% weight), and an oral final exam (50% weight); the final grade is the outcome of their average. The written test consists of a test with 30 questions with closed answers (4 answers for each question), one mark for every correct answer, no penalisation for wrong answers. Minimum pass grade is 18/30.
Students who passed the written exam will be allowed to take the oral exam immediately after or in the course of any call of the same session.
The criteria for grading the oral part of the exam are as follows:
o 18-20: barely sufficient knowledge and comprehension of topics, possibly with flaws; sufficient level of analysis synthesis and autonomous judgment
o 21-23: Standard knowledge and comprehension of topics; correct analysis and synthesis, logically coherent reasoning
o 24-26: Fairly good knowledge and comprehension of topics; good analytical and synthetical abilities, logically rigorous reasoning.
o 27-29: Full knowledge and comprehension of topics; remarkable analytical and synthetical abilities. Good judgmental autonomy.
o 30-30L: Very good level of knowledge and comprehension of topics. Outstanding capabilities of analysis and synthesis and of autonomous judgment. Ability for reasoning in a personal way.
EN
IT
Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
ll corso intende insegnare agli studenti i concetti di base del diritto pubblico e fornire una prima introduzione in relazione all'ordinamento giuridico italiano, a quello europeo e globale. Saranno analizzati la struttura dei sistemi giuridici e degli ordinamenti giuridici, nonché i fondamenti del costituzionalismo. Il corso offrirà una conoscenza più approfondita della regolamentazione e della protezione dei diritti fondamentali, del diritto e delle procedure amministrative, della regolamentazione giuridica dell'economia e delle finanze pubbliche.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti, anche attraverso una attività personale di approfondimento di casi e attraverso l'analisi di materiali, sapranno leggere e interpretare testi dottrinali, normativi e giurisprudenziali, acquisendo dimestichezza nella comprensione di testi giuridici.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti impareranno a conoscere i principi e gli istituti fondamentali del diritto pubblico e a leggere i fenomeni giuridici, anche nell'ottica di una prospettiva pratica e critica, comunque di base.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Agli studenti sarà richiesto di contestualizzare problemi e questioni di diritto pubblico, anche attraverso la comparazione tra diversi ordinamenti.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti discuteranno in classe casi, materiali e atti normativi, acquisendo dimestichezza con il lessico giuridico e sufficiente padronanza di base nell'argomentazione.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti acquisiranno il metodo e le conoscenze di base nel campo del diritto pubblico e delle scienze giuridiche, sufficienti per affrontare ulteriori specializzazioni, così come per prime applicazioni pratiche.
Learning Objectives
LEARNING OUTCOMES:
The course intends to make students familiar with the fundaments of public law through a comprehensive introduction to the Italian legal system, the European one and the global environment. The structure of the legal systems and legal orders, as well as the fundamentals of public law, will be analyzed. The course will offer a deep knowledge of fundamental rights, administrative law and procedures, regulation and public finance.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students - also through a personal in-depth study of cases and reading of materials - will be able to read and interpret doctrinal texts, legislation and case studies, thus becoming familiar with the main tools for understanding public law.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be provided with a basic level of critical thinking on public law, also in a practical perspective.
MAKING JUDGEMENTS:
Students will be asked to read public law in context, also by comparing different jurisdictions.
COMMUNICATION SKILLS:
Students will discuss in the class cases, materials and statutes, becoming familiar with legal vocabulary and tools, necessary in order to develop communicative skills on legal phenomena.
LEARNING SKILLS:
The course provides students with basic methodology and the foundational notions of public law and legal sciences, necessary for subsequent studies in Masters degree as well as for first pratical implementation.
Programma
PRIMA SETTIMANA:
1. ll metodo negli studi di diritto; nozione di diritto
2. Due famiglie di sistemi giuridici: common law e civil law
3. Origini e caratteristiche dello stato moderno
SECONDA SETTIMANA:
1. Diritto pubblico nazionale e internazionale
2. Fonti del diritto
3. Federalismo e regionalismo
TERZA SETTIMANA:
1. Rapporti tra ordinamenti giuridici: a) l'ordinamento giuridico dell'Unione europea
2. Rapporti tra ordinamenti giuridici: b) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
3. Rapporti tra ordinamenti giuridici: c) l'arena globale
QUARTA SETTIMANA:
1. (segue) Rapporti tra ordinamenti giuridici: d) schemi transnazionali
2. Diritto pubblico e potere politico: forme di governo - separazione dei poteri
3. Diritto pubblico e potere politico: lo stato costituzionale
QUINTA SETTIMANA:
1. Il ruolo del potere giudiziario: modelli di controllo costituzionale della legislazione
2. Il ruolo del potere giudiziario: la giustizia nell'amministrazione - stato di diritto
3. Il ruolo del potere giudiziario: la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà (I)
SESTA SETTIMANA:
1. (segue) Diritti fondamentali e libertà (II): proporzionalità e bilanciamento
2. Diritto amministrativo e agenzie amministrative: a) principio di legalità
3. Diritto amministrativo e agenzie amministrative: b) procedimenti amministrativi; lo Stato regolatore
Program
WEEK ONE:
1. Issues of methods in legal studies; concept of law
2. Two families of Legal Systems: Civil Law and Common Law
3. Origins and features of the modern Nation-State
WEEK TWO:
1. Domestic and International Public Law
2. Sources of Law
3. Federalism and regionalism
WEEK THREE:
1. Legal orders relationships: a) the European Union legal system
2. Legal orders relationships: b) the European Convention of Human Rights
3. Legal orders relationships: c) the Global arena
WEEK FOUR:
1. (cont'd:) Legal orders relationships: d) transnational patterns
2. Public law and political power: forms of government – separation of powers
3. Public law and political power: the Constitutional State
WEEK FIVE:
1. The role of the judiciary: patterns of constitutional review of the legislation
2. The role of the judiciary:
3. The role of the judiciary: protection of fundamental rights and freedoms (I)
WEEK SIX:
1. (cont'd) Protection of fundamental rights and freedoms (II): proportionality and balancing
2. Administrative law and administrative agencies: a) rule of law
3. Administrative law and administrative agencies: b) administrative proceedings; the regulatory State
Testi Adottati
Studenti frequentanti
1. Textbook: Andrea Buratti, Western Constitutionalism, 3rd edition, Giappichelli-Springer, 2023, ISBN 9791221101683
2. Casi e materiali discussi in classe, caricati sul sito web del corso e elencati ogni anno nel Sillabo
Books
Attending students
1. Textbook: Andrea Buratti, Western Constitutionalism, 3rd edition, Giappichelli-Springer, 2023, ISBN 9791221101683
2. Required materials and readings as discussed in class, uploaded in the course's website and as pointed out in the annual Syllabus
Bibliografia
Masterman - Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019
M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford University Press, 2010
Bibliography
Masterman - Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019
M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford University Press, 2010
Modalità di svolgimento
36 ore, ripartite in 18 lezioni di 2 ore ciascuna, nel primo semestre, tre volte a settimana.
Teaching methods
36 hours divided into 18 classes, two hours' each, during the first semester, thrice a week.
Regolamento Esame
I risultati dell'apprendimento sono valutati attraverso una prova scritta (50% ) e un esame finale orale (50% ), il cui peso è equivalente; la votazione finale è il frutto della loro media. La prova scritta consiste in un test di 30 domande a risposte chiuse (4 risposte per ogni domanda), un punto per ogni risposta esatta, nessuna penalizzazione per risposte erronee. Punteggio minimo di sufficienza è 18/30.
Gli studenti che hanno superato l'esame scritto potranno sostenere l'orale contestualmente oppure in altro appello nella stessa sessione di esami.
Di seguito i criteri per l'attribuzione del punteggio orale:
o 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
o 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
o 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
o 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
o 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità
di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo
originale.
Exam Rules
Learning outcomes are assessed through a written test (50% weight), and an oral final exam (50% weight); the final grade is the outcome of their average. The written test consist of a test with 30 questions with closed answers (4 answers for each question), one mark for every correct answer, no penalisation for wrong answers. Minimum pass grade is 18/30.
Students who passed the written exam will be allowed to take the oral exam immediately after or in the course of any call of the same session.
The criteria for grading the oral part of the exam are as follows:
o 18-20: barely sufficient knowledge and comprehension of topics, possibly with flaws; sufficient level of analysis synthesis and autonomous judgment
o 21-23: Standard knowledge and comprehension of topics; correct analysis and synthesis, logically coherent reasoning
o 24-26: Fairly good knowledge and comprehension of topics; good analytical and synthetical abilities, logically rigorous reasoning.
o 27-29: Full knowledge and comprehension of topics; remarkable analytical and synthetical abilities. Good judgmental autonomy.
o 30-30L: Very good level of knowledge and comprehension of topics. Outstanding capabilities of analysis and synthesis and of autonomous judgment. Ability for reasoning in a personal way.
EN
IT
Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
ll corso intende insegnare agli studenti i concetti di base del diritto pubblico e fornire una prima introduzione in relazione all'ordinamento giuridico italiano, a quello europeo e
globale. Saranno analizzati la struttura dei sistemi giuridici e degli ordinamenti giuridici, nonché i fondamenti del costituzionalismo. Il corso offrirà una conoscenza più approfondita
della regolamentazione e della protezione dei diritti fondamentali, del diritto e delle procedure amministrative, della regolamentazione giuridica dell'economia e delle finanze
pubbliche.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti - anche attraverso una attività personale di approfondimento di casi e attraverso l'analisi di materiali - sapranno leggere e interpretare testi dottrinali, normativi e
giurisprudenziali, acquisendo dimestichezza nella comprensione di testi giuridici.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti impareranno a conoscere i principi e gli istituti fondamentali del diritto pubblico e a leggere i fenomeni giuridici, anche nell'ottica di una prospettiva pratica e critica,
comunque di base.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Agli studenti sarà richiesto di contestualizzare problemi e questioni di diritto pubblico, anche attraverso la comparazione tra diversi ordinamenti.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti discuteranno in classe casi, materiali e atti normativi, acquisendo dimestichezza con il lessico giuridico e sufficiente padronanza di base nell'argomentazione.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti acquisiranno il metodo e le conoscenze di base nel campo del diritto pubblico e delle scienze giuridiche, sufficienti per affrontare ulteriori specializzazioni, così come per prime applicazioni pratiche.
Learning Objectives
LEARNING OUTCOMES:
The course intends to make students familiar with the fundamentals of public law through a comprehensive introduction to the Italian legal system, the European one and the global environment. The structure of the legal systems and legal orders, as well as the fundamentals of public law, will be analyzed. The course will offer a deep knowledge of
fundamental rights, administrative law and procedures, regulation and public finance.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students - also through a personal in-depth study of cases and reading of materials - will be able to read and interpret doctrinal texts, legislation and case studies, thus becoming
familiar with the main tools for understanding public law.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be provided with a basic level of critical thinking on public law, also in a practical perspective.
MAKING JUDGEMENTS:
Students will be asked to read public law in context, also by comparing different jurisdictions.
COMMUNICATION SKILLS:
Students will discuss in the class cases, materials and statutes, becoming familiar with legal vocabulary and tools, necessary in order to develop communicative skills on legal
phenomena.
LEARNING SKILLS:
The course provides students with basic methodology and the foundational notions of public law and legal sciences, necessary for subsequent studies in Masters degree as well
as for first pratical implementation.
Programma
ll metodo negli studi di diritto
I sistemi giuridici: common law e civil law
Origini e caratteristiche dello stato
Diritto pubblico nazionale e internazionale
Federalismo e regionalismo
Rapporti degli ordini legali: a) l'ordinamento giuridico dell'Unione europea
Rapporti degli ordini legali: b) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Rapporti degli ordini legali: c) l'arena globale
Rapporti degli ordini legali: d) schemi transnazionali
Forme di governo - separazione dei poteri
Lo stato costituzionale: fonti del diritto
Modelli di revisione costituzionale della legislazione
Diritti fondamentali e libertà (I)
Diritti fondamentali e libertà (II)
Diritto amministrativo e agenzie amministrative: a) Stato di diritto
Diritto amministrativo e agenzie amministrative: b) procedimenti amministrativi Diritto amministrativo e agenzie ammin
Program
Issues of methods in legal studies
The Legal Systems: Civil and Common Law
Origins and features of the Nation-State
Domestic and International Public Law
Federalism and regionalism
Legal orders relationships: a) the European Union legal system
Legal orders relationships: b) the European Convention of Human Rights
Legal orders relationships: c) the Global arena
Legal orders relationships: d) transnational patterns
Forms of government – separation of powers
The Constitutional State: sources of law
Patterns of constitutional review of the legislation
Fundamental rights and freedoms (I)
Fundamental rights and freedoms (II)
Administrative law and administrative agencies: a) rule of law
Administrative law and administrative agencies: b) administrative proceedings
Administrative law and administrative agencies: c) remedies
The regulatory State
Testi Adottati
Studenti frequentanti
1. Textbook: Masterman - Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019 (selezione di capitoli indicata nel Sillabo annuale)
2. Casi e materiali distribuiti in classe, caricati sul sito web del corso e elencati ogni anno nel Sillabo
Studenti non frequentanti:
Textbook: Masterman Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019
Books
Students attendig classes:
1. Textbook: Masterman - Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019 (selected chapters as pointed out in the annual syllabus)
2. Required materials and Readings circulated in class, uploaded in the course's website and as pointed out in the annual Syllabus
Students not attending classes:
Textbook: Masterman Schutze, The Oxford Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019 (whole text)
Bibliografia
A. Buratti, Western Constitutionalism. History, Institutions, Comparative Law, Giappichelli-Springer, II ed., 2019
M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford University Press, 2010
Bibliography
A. Buratti, Western Constitutionalism. History, Institutions, Comparative Law, Giappichelli-Springer, II ed., 2019
M. Loughlin, Foundations of Public Law, Oxford University Press, 2010
Modalità di svolgimento
36 ore, ripartite in 18 lezioni di 2 ore ciascuna, nel primo semestre, tre volte a settimana.
Teaching methods
36 hours divided into 18 classes, two hours' each, during the first semester, thrice a week.
Regolamento Esame
I risultati dell'apprendimento sono valutati attraverso una prova scritta (50% ) e un esame finale orale (50% ). La partecipazione attiva alle lezioni sarà considerata in sede di discussione orale.
Gli studenti che hanno superato l'esame scritto potranno sostenere l'orale nella stessa sessione di esami, oppure nel corso dello stesso anno accademico.
Exam Rules
Learning outcomes are assessed through a written exam (50% weight), and an oral final exam (50% weight). Active participation in class will be consdiered in the course of the oral exam.
Students who passed the written exam will be allowed to take the oral exam in the course of any call of the same A.Y.
Aggiornato A.A. 2021-2022
- Overview
The course intends to make students familiar with the basic concepts of law though a comprehensive introduction to the Italian legal system, the European one and the global environment. The structure of the legal systems and legal orders, as well as the fundamentals of public law, will be analyzed. The course will offer a deep knowledge of fundamental rights regulation and protection, administrative law and procedures, legal regulation of economics and public finance.
- Course content and structure
Issues of methods in legal studies
The Legal Systems: Civil and Common Law
Federalism and regionalism
Origins and features of the Nation-State
The Constitutional State: sources of law
Patterns of constitutional review of the legislation
Domestic and International Public Law
Legal orders relationships: a) the European Union legal system; b) the European Convention of Human Rights; c) the Global arena; d) transnational patterns
Forms of government – separation of powers
Parliaments
Governments
Administrations: a) rule of law; b) administrative proceedings ;c) remedies
Fundamental rights and freedoms
The required textbook for this course is:
- The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law, edited by Roger Masterman and Robert Schutze, Cambridge University Press 2019, ISBN-10 : 1107167817; ISBN-13 : 978-1107167810;
For further details please refer to the Syllabus, published on line under "Materiale Didattico"
Aggiornato A.A. 2020-2021
- Overview
The course intends to make students familiar with the basic concepts of law though a comprehensive introduction to the Italian legal system, the European one and the global environment. The structure of the legal systems and legal orders, as well as the fundamentals of public law, will be analyzed. The course will offer a deep knowledge of fundamental rights regulation and protection, administrative law and procedures, legal regulation of economics and public finance.
- Course content and structure
Issues of methods in legal studies
The Legal Systems: Civil and Common Law
Federalism and regionalism
Origins and features of the Nation-State
The Constitutional State: sources of law
Patterns of constitutional review of the legislation
Domestic and International Public Law
Legal orders relationships: a) the European Union legal system; b) the European Convention of Human Rights; c) the Global arena; d) transnational patterns
Forms of government – separation of powers
Parliaments
Governments
Administrations: a) rule of law; b) administrative proceedings ;c) remedies
Fundamental rights and freedoms
The required textbook for this course is:
- The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law, edited by Roger Masterman and Robert Schutze, Cambridge University Press 2019, ISBN-10 : 1107167817; ISBN-13 : 978-1107167810;
For further details please refer to the Syllabus, published on line under "Materiale Didattico"



 Prof.ssa Lucia Leonelli
Prof.ssa Lucia Leonelli