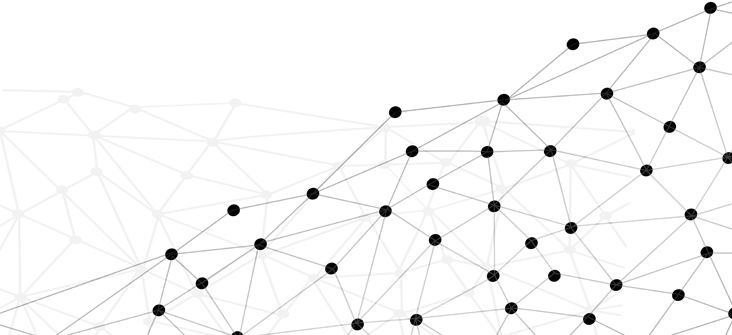EN
IT
Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Comprensione dettagliata del funzionamento dei mercati monetari in economia chiusa e aperta; conoscenza delle determinanti del tasso di cambio e dei modelli di crisi valutarie; comprensione della teoria delle aree valutarie ottimali e dei costi e dei benefici di un'unione monetaria; comprensione del processo di transizione verso l'unione monetaria e delle fragilità delle unioni incomplete; conoscenza del ruolo della BCE e di quello dell'euro nei mercati internazionali; comprensione delle regole e dei trattati che governano il funzionamento dell'unione monetaria e delle implicazioni per la politica monetaria e fiscale (crisi dell'euro, crisi del debito, regole fiscali); comprensione delle riforme necessarie a completare l'unione monetaria.
Apprendimento di un approccio analitico e statistico per l'analisi delle questione economiche, in grado di rafforzare ed estendere le conoscenze maturate nel corso del primo ciclo e consentire di elaborare e/o applicare idee originali, anche in un contesto di ricerca.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Le nozioni, i concetti ed i modelli teorici appresi consentono di comprendere in maniera più chiara ed organica le ragioni dell'integrazione monetaria europea e le sue implicazioni, e di poter formulare delle proposte concrete di politica economica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Quanto appreso può essere utilizzato in nuovi ambiti e in un contesto lavorativo nella gestione dei rapporti con le istituzioni europee.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Quanto appreso può essere utilizzato per valutare in maniera critica, costruttiva e senza pregiudizi l'operato dei policymaker nazionali ed europei e le riforme proposte. Alla fine del corso gli studenti avranno compreso la complessità dei problemi inerenti all'unione monetaria europea e saranno in grado di anticiparne i possibili sviluppi.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Sapere presentare fatti e meccanismi complessi in maniera rigorosa; imparare a presentare fatti complessi in maniera semplice, comunicando le conclusioni e conoscenze e la ratio ad essi sottesa, a interlocutori specialisti e non specialisti.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Il corso si propone di fornire un metodo per l'apprendimento futuro. Ci si attende che al termine del corso gli studenti abbiano acquisto la capacità di saper decodificare testi ufficiali, paper scientifici e banche dati, e che siano capaci di continuare a studiare in modo auto-diretto o autonomo.
Gli studenti saranno incentivati a sviluppare alcuni soft skill come: flessibilità, integrità, etica del lavoro, senso di responsabilità e capacità di relazionarsi con gli a altri in maniera positiva e cooperativa.
Learning Objectives
LEARNING OUTCOMES:
Deep understanding of the functioning of the monetary markets in closed and in open economy; knowledge of the determinants of exchange rates and of currency crisis models; understanding the theory of optimum currency areas, and costs and the benefits of monetary unions; comprehension of the transition process towards a monetary union and of the fragility of incomplete monetary unions; in-depth understanding of the role of the ECB, and of the role of the euro in international markets; comprehension of the economic implications of the rules and treaties governing the economic functioning of the EMU and of the related implications for the conduct of monetary and fiscal policies (euro crisis, fiscal rules, sovereign debt crisis); understanding the importance of reforms to complete the monetary union.
Learning of an analytical and quantitative approach for economic analysis so to strengthen what already learned during the first cycle and be able to apply these tools in an innovative way, also in research contexts.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To give students familiarity with a broad range of European monetary and fiscal policy issues; to ensure a good knowledge of the economic grounding of the European monetary integration and of the related fragilities; to show students the usefulness of simple analytical models in understanding the relevant aspects of European integration and to give them the ability to apply these analytical tools intelligently.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
What is learned can be applied to other situations and to actual work in the context of European institutions and/or national and local public administrations subject to European directives and regulations.
MAKING JUDGEMENTS:
•What is learned can be used to assess critically and without prejudices: i) the activity and the decisions of national and European policymakers; ii) the reforms on the agenda. Students will be able to understand novel and complex problems related to the process of economic integration and speculate on future evolutions of the EMU.
COMMUNICATION SKILLS:
Be able to rigorously present facts and complex mechanisms; learn how to present complex facts and economic mechanisms in a comprehensive manner and communicate the relative conclusions, knowledge and rationale to specialists and non-specialized audiences.
LEARNING SKILLS:
The course aims at providing students with the tools necessary for future learning. At the end of the course students are expected to be able to read and understand official documents, scientific articles and databases. Students are also expected to be develop autonomous learning abilities.
Special attention will be given to help students develop their soft skills, such as flexibility, integrity and work ethic, positive attitude, responsibility, teamwork and interpersonal skills. I
Prerequisiti
Gli studenti devono avere familiarità con i concetti e i modelli di base di microeconomia, macroeconomia e di teoria dei giochi.
Prerequisites
Students are expected to be familiar with basic microeconomic and macroeconomic concepts and models, and with elements of game theory.
Programma
1) Elementi di economia monetaria
2) Tassi di cambio, la parità scoperta dei tassi d'interesse e la mobilità internazionale dei capitali
3) Politica monetaria in economia aperta e crisi valutarie
4) I costi e i benefici della moneta unica
5) La teoria delle aree valutarie ottimali
6) La fragilità delle aree monetarie incomplete
4) Il processo d'integrazione monetaria europa
a) Storia (Bretton Woods, Il serpente monetario, il sistema monetario europeo e la crisi del 1992-1993)
b) Criteri di Maastricht e convergenza
c) La transizione verso l'unione monetaria europea
5) La banca centrale europea
a) Obiettivi, strumenti e strategie
b) Misure non convenzionali
c) Benefici della stabilità dei prezzi
d) Efficacia della politica monetaria
e) Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria
f) Indipendenza e trasparenza
g) Una moneta e tanti tassi d'inflazione
6) Politica fiscale nelle unioni monetarie
a) Interazione tra politica monetaria e fiscale
b) Sostenibilità fiscale
c) Vincoli fiscale nell'unione monetaria europea
d) Rischi di default e di bailout in un'unione monetaria
6) La crisi dell'eurozona
a) Il contagio dagli USA
b) La crisi del debito sovrano
c) La risposta della BCE alla crisi
d) Politica fiscale e crisi
7) Il futuro dell'eurozona
Program
1) Elements of monetary economics
2) Exchange rates, uncovered interest parity and perfect capital mobility
3) Monetary policy in open economy and currency crisis
4) The costs and the benefits of common currency
5) The theory of optimal currency areas
6) The fragility of incomplete monetary unions
4) The process of European monetary integration
a) History (Bretton Woods, Europe's snake, the European Monetary System, the crisis of
1992-1993)
b) Maastricht criteria and convergence
c) The transition towards the EMU
5) The European Central Bank
a) Objectives, instruments and strategy
b) Non-standard measures
c) Benefits of price stability
d) Scope of monetary policy
e) The transmission mechanism of monetary policy
f) Independence and accountability
g) One currency and many inflation rates
6) Fiscal policy in monetary unions
a) Interactions between monetary and fiscal policies
b) Fiscal sustainability
c) Fiscal constraints in the EMU
d) Risks of default and bailout in a monetary union
6) The Eurozone crisis
a) The contagion from the US
b)The sovereign debt crisis
c) The ECB's pesponse to the financial crisis
d) Euro Area fiscal policies and the crisis
7) The future of the Eurozone
Testi Adottati
Baldwin, Richard and Wyplosz, Charles (2019), The Economics of European Integration, 6th edition, McGraw Hill.
De Grauwe Paul (2018), The Economics of Monetary Union, 12th edition, Oxford University Press.
Books
Baldwin, Richard and Wyplosz, Charles (2019), The Economics of European Integration, 6th edition, McGraw Hill.
De Grauwe Paul (2018), The Economics of Monetary Union, 12th edition, Oxford University Press.
Bibliografia
Blanchard, O., Amighini A., Giavazzi F., (2015), Macroeconomics, A European Perspective,2nd edition, Pearson.
Eichengreen B., (2010), The Breakup of the Euro Area, in Europe and the Euro (A. Alesina and F. Giavazzi, editors), The University of Chicago Press.
Eichengreen, B., Wyplosz C., (1998) The Stability Pact: more than a minor nuisance?, Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 13(26), pages 65-113, 04.
Eichengreen, B., Wyplosz, C., (2016). Minimal Conditions for the Survival of the Euro. Intereconomics, 51(1), pp.24-28.
Kenen, P. (1969) The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, in R.Mundell and A. Swoboda eds, Monetary Problems of the International Economy, The University of Chicago Press.
Krugman P. (2012) The revenge of optimum currency area, Chapter in NBER book NBER Macroeconomics Annual 2012, Volume 27 (2013).
Mundell, R. (1961) A theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, 51 (4).
Obstfeld M., (1996) Models of Currency Crises with Self-Fulfilling Features, European Economic Review, vol. 40, pp. 1037-1047
Wyplosz, C. (2006). European Monetary Union: the dark sides of a major success, Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 21(46), pages 207-261,
Bibliography
Blanchard, O., Amighini A., Giavazzi F., (2015), Macroeconomics, A European Perspective,2nd edition, Pearson.
Eichengreen B., (2010), The Breakup of the Euro Area, in Europe and the Euro (A. Alesina and F. Giavazzi, editors), The University of Chicago Press.
Eichengreen, B., Wyplosz C., (1998) The Stability Pact: more than a minor nuisance?, Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 13(26), pages 65-113, 04.
Eichengreen, B., Wyplosz, C., (2016). Minimal Conditions for the Survival of the Euro. Intereconomics, 51(1), pp.24-28.
Kenen, P. (1969) The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, in R.Mundell and A. Swoboda eds, Monetary Problems of the International Economy, The University of Chicago Press.
Krugman P. (2012) The revenge of optimum currency area, Chapter in NBER book NBER Macroeconomics Annual 2012, Volume 27 (2013).
Mundell, R. (1961) A theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, 51 (4).
Obstfeld M., (1996) Models of Currency Crises with Self-Fulfilling Features, European Economic Review, vol. 40, pp. 1037-1047
Wyplosz, C. (2006). European Monetary Union: the dark sides of a major success, Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 21(46), pages 207-261,
Modalità di svolgimento
Metodi d’insegnamento
- Lezioni frontali
- Esercitazioni per le quali è richiesta una partecipazione attiva da parte degli studenti
- Studio di casi pratici
Metodi di apprendimento
- Frequentare le attività didattiche in maniera attiva
- Prendere appunti in maniera organica ed intelligente
- Ricercare il materiale in biblioteca e on-line
- Studiare i testi di riferimento e le letture di base
- Leggere e studiare i documenti ufficiali (trattati, direttive, regolamenti, rapporti ecc...)
Teaching methods
Teaching methods
- Lectures
- Tutorials with active student participation
- Case studies and discussions
Learning methods
- Active class participation
- Taking notes in class
- Search for study material in the library and on-line
- Studying the assigned basic readings on textbooks, handouts and journal articles
- Reading and studying official documents (treaties, directives, regulations, reports etc...)
Regolamento Esame
Esame scritto e orale su tutto il programma.
Esame scritto e orale su tutto il programma.
Sistema di voto e criteri di valutazione
Il sistema di voto si basa sul sistema italiano di valutazione che varia da 18/30 a 30/30. Nello specifico, il voto più alto è 30/30 con lode, mentre quello più basso è 18/30. Gli esami con voto inferiore a 18/30 sono considerati “non superati”.
La prova scritta e quella orale valutano la preparazione complessiva dello studente, la capacità di integrare (e collegare) le conoscenze delle diverse parti del programma, la consequenzialità del ragionamento, la capacità analitica e l'autonomia di giudizio. Come criteri aggiuntivi, saranno presi in considerazione la proprietà della lingua e la chiarezza di presentazione, in accordo con i risultati di apprendimento generali e specifici descritti in questo modulo (conoscenza e comprensione; capacità di applicare conoscenza e comprensione; autonomia di giudizio; capacità di apprendimento; capacità di comunicazione).
Exam Rules
Written and oral exam on the whole programme.
Grading policy and assessment criteria
Grading is based on the Italian Grading System ranges from 18/30 to 30/30. Specifically, the highest mark is 30/30 with distinction (defined as “lode” in Italian), while the lower is 18/30. Exams under 18/30 are considered as “not passed”.
The written and oral exams evaluate the overall preparation of the student, the ability to integrate (and connect) the knowledge of the different parts of the program, the consequentiality of the reasoning, the analytical capacity, and the autonomy of judgment. As additional criteria, the property of language and clarity of presentation, in accordance with the general and the specific learning outcomes already described in this form (i.e., knowledge and understanding; ability to apply knowledge and understanding; autonomy of judgment; learning skills; communication skills), will be taken into consideration.
Modalità di frequenza
La frequenza non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata.
Ci si aspetta che gli studenti partecipino alle lezioni in maniera attiva.
Attendance Rules
Class attendance is not compulsory, but it is strongly recommended.
Students are expected to actively participate to class activities.
Aggiornato A.A. 2021-2022
Aggiornato A.A. 2021-2022
Master of Science in European Economy & Business Law
Economics of European Integration
Academic Year 2021-2022
Lecturer: Prof. Barbara Annicchiarico
E-mail address: barbara.annicchiarico@uniroma2.it
E-mail policy: See here
Office Hour: On Teams by appointment.
Credits - CFU: 6
Teams link: click here
Syllabus Updates and Material: Students are advised to regularly check for syllabus updates. Handouts and presentations will be available in due course.
Description of the Course
The course introduces students to the economics analysis of the European Monetary Union. The course will cover economic concepts, models and tools developed in the field of international economics and macroeconomics that are particularly suited to provide students with a better understanding of the process of monetary integration.
Prerequisites
Students are expected to be familiar with basic microeconomic and macroeconomic concepts and models, and with elements of game theory. A quantitative background is not strictly required, but students will benefit from knowledge of mathematics and statistics. The course is held in English
Learning outcomes
Deep understanding of the functioning of the monetary markets in closed and in open economy; knowledge of the determinants of exchange rates and of currency crisis models; understanding the theory of optimum currency areas, and costs and the benefits of monetary unions; comprehension of the transition process towards a monetary union and of the fragility of incomplete monetary unions; in-depth understanding of the role of the ECB, and of the role of the euro in international markets; comprehension of the economic implications of the rules and treaties governing the economic functioning of the EMU and of the related implications for the conduct of monetary and fiscal policies (euro crisis, fiscal rules, sovereign debt crisis); understanding the importance of reforms to complete the monetary union.
Learning of an analytical and quantitative approach for economic analysis so to strengthen what already learned during the first cycle and be able to apply these tools in an innovative way, also in research contexts.
Knowledge and understanding
To give students familiarity with a broad range of European monetary and fiscal policy issues; to ensure a good knowledge of the economic grounding of the European monetary integration and of the related fragilities; to show students the usefulness of simple analytical models in understanding the relevant aspects of European integration and to give them the ability to apply these analytical tools intelligently.
Applying knowledge and understanding
What is learned can be applied to other situations and to actual work in the context of European institutions and/or national and local public administrations subject to European directives and regulations.
Making judgements
What is learned can be used to assess critically and without prejudices: i) the activity and the decisions of national and European policymakers; ii) the reforms on the agenda. Students will be able to understand novel and complex problems related to the process of economic integration and speculate on future evolutions of the EMU.
Communication skills
Be able to rigorously present facts and complex mechanisms; learn how to present complex facts and economic mechanisms in a comprehensive manner and communicate the relative conclusions, knowledge and rationale to specialists and non-specialized audiences.
Learning skill
The course aims at providing students with the tools necessary for future learning. At the end of the course students are expected to be able to read and understand official documents, scientific articles and databases. Students are also expected to be develop autonomous learning abilities.
Special attention will be given to help students develop their soft skills, such as flexibility, integrity and work ethic, positive attitude, responsibility, teamwork and interpersonal skills.
Teaching method
Online lectures, but students will be asked to participate actively. During the course I will sometimes use Matlab to show some stylized facts. Simple codes will be provided for replication.
Exams
Written and oral examination on all programme. Different rules apply whether the exam will be held in presence or in remote. See the exam rules page or Presentation #0. Teams link for exams.
Grading Policy
Please note that a grade of 30/30 represents achievement that is outstanding relative to the level necessary to meet course requirements (students must show an excellent knowledge of the subject, all written work must be well written, competent and accurate; sloppiness of any kind will prevent a student from getting 30/30 as final grade, no matter if the student feels she/he is well prepared). Bargaining on grading is not allowed. Notice that grading is based on performance rather than effort. If you are not happy with the grade, just improve the performance. It is not possible to submit extra work in the attempt to improve a grade.
Zero tolerance for academic dishonesty
Academic dishonesty includes cheating on exams, plagiarism, improper citation, recycled work, unauthorized assistance, or similar actions. Assignments and projects are specific to individual courses; presenting the same work in two different courses (including previous courses) is considered recycling and is unacceptable.
Students who commit an act of academic dishonesty will receive a failing grade. See also the Exam Rules.
Attedance and Behavior
Syllabus
Last update: 13th October 2021
IMPORTANT: This syllabus will be subject to changes and updates during the course. The final reading list for each topic will be available step by step. In this way I'll be able to tailor the contents of this course to students' needs, interests and background. Please check this syllabus on a regular basis for any updates.
Please notice that
1. Basic Maths and Macroeconomic Tools
- Logarithms, log-linearization, differential equations and difference equations
- Money demand and supply
- Expectations
-
Open Economy Aspects
Final Readings
- Logarithms, log-linearization, differential equations and difference equations
-
Money demand and supply
- Expectations
-
Open Economy Aspects
-
*BW-2019: chapter 13 + Annex on various exchange rate regimes
-
*Presentation #4
-
*Presentation #5
-
Kenneth Rogoff (1996) The Purchasing Power Parity Puzzle, Journal of Economic Literature, Vol. 34, No. 2. pp. 647-668.
-
Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh & Alan M. Taylor (2005). "The Trilemma in History: Tradeoffs Among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility" in The Review of Economics and Statistics, Vol. 87, No. 3, pp. 423--438.
2. Exchange Rates Determinants and the Euro/Dollar Exchange Rate
Final Readings
3. Macroeconomics of Monetary Integration
Final Readings
-
-
*BW-2019: chapter 15
-
*Paul Krugman (2012) "The revenge of optimum currency area", Chapter in NBER book NBER Macroeconomics Annual 2012, Volume 27 (2013).
-
Kenen, P. (1969) "The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View" in R.Mundell and A. Swoboda eds, Monetary Problems of the International Economy, The University of Chicago Press.
-
Mundell, R. (1961) A theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, 51 (4).
4. European Monetary Union - The Transition to the EMU
-
The transition to a monetary union
-
The 5 entry conditions (Maastricht Criteria): Why convergence requirements?
-
How to fix the conversion rates
- Inflation and productivty in a monetary union - the Balassa-Samuelson effect
Final Readings
5. European Monetary Union - Functioning and Fragilities
Final Readings
-
*Presentations #14 and #15
-
*BW-2019: chapter 16: sections from 16.3* to 16.7*
-
*ECB website contents (see the above links). All the material MUST be covered* (this is summarized in Presentation 14)
-
*DG-2020: chapter 5
-
* The transmission mechanism of monetary policy - The Monetary Policy Committee - Bank of England
6. Fiscal Policy
-
The Government Budget Constraint
-
Fiscal and monetary policy interactions
-
Fiscal policy in a monetary union
-
Fiscal policy externalities
-
Stability and Growth Pact
-
Fiscal Compact
Final Readings
-
*Barry Eichengreen & Charles Wyplosz, 1998. "The Stability Pact: more than a minor nuisance?," Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 13(26), pages 65-113, 04.
-
ECB on the Fiscal Compact see here
-
Thomas J. Sargent & Neil Wallace (1981) Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review vol. 5, no 3.
-
Buiter, W.H. & Corsetti, G. & Roubini, N., 1992. Excessive Deficits: Sense and Nonsence in the Treaty of Maastricht, available here.
-
M. Wickens (2008), Macroeconomic Theory, Princenton University Press, chapter 5.
6. Eurozone Crisis
- Bubbles
-
The subprimes follies and the great recession
-
Sovreign Debt Crisis
-
Managing the Crisis and the EMS
-
Lessons from the crisis: How to complete the monetary union and conditions for the survival of the Euro
Final Readings
- Presentation #18 (optional)
-
*Presentations #19-22
-
*BW-2019: chapter 19
-
*DG-2020: chapter 7
-
*Barry Eichengreen, Charles Wyplosz, (2016) Minimal conditions for the survival of the euro
- *Paul De Grauwe, Yuemei Ji, Fiscal implications of the ECB's bond-buying programme, 14 June 2013, VoxEU.
-
Barry Eichengreen (2008), Sui generis EMU, European Economy, Economic Papers 303, February 2008.
-
Charles Wyplosz, (2006). "European Monetary Union: the dark sides of a major success," Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 21(46), pages 207-261, 04
7. Current and future prospects
- Black Swan scenarios and economic fiction stories
- Current and future challenges
Final Readings
Books
-
BW-2019: Baldwin, Richard and Wyplosz, Charles (2019), The Economics of European Integration, 6th edition, McGraw Hill. This book represents an ESSENTIAL READING for this course.
-
DG-2020: De Grauwe Paul (2020), The Economics of Monetary Union, 13th edition, Oxford University Press. This book represents an ESSENTIAL READING for this course.
- BAG-2017: Blanchard, O., Amighini A., Giavazzi F., (2017), Macroeconomics, A European Perspective, 3rd edition, Pearson.
Aggiornato A.A. 2020-2021
Aggiornato A.A. 2020-2021
Master of Science in European Economy & Business Law
Economics of European Integration
Academic Year 2020-2021
Lecturer: Prof. Barbara Annicchiarico
E-mail address: barbara.annicchiarico@uniroma2.it
E-mail policy: See here
Office Hour: I haven't an open-door policy. Please respect office hours. Check here
Credits - CFU: 6
Teams link: click here
Syllabus Updates and Material: Students are advised to regularly check for syllabus updates. Handouts and presentations will be available in due course.
Description of the Course
The course introduces students to the economics analysis of the European Monetary Union. The course will cover economic concepts, models and tools developed in the field of international economics and macroeconomics that are particularly suited to provide students with a better understanding of the process of monetary integration.
Prerequisites
Students are expected to be familiar with basic microeconomic and macroeconomic concepts and models, and with elements of game theory. A quantitative background is not strictly required, but students will benefit from knowledge of mathematics and statistics. The course is held in English
Learning outcomes
Deep understanding of the functioning of the monetary markets in closed and in open economy; knowledge of the determinants of exchange rates and of currency crisis models; understanding the theory of optimum currency areas, and costs and the benefits of monetary unions; comprehension of the transition process towards a monetary union and of the fragility of incomplete monetary unions; in-depth understanding of the role of the ECB, and of the role of the euro in international markets; comprehension of the economic implications of the rules and treaties governing the economic functioning of the EMU and of the related implications for the conduct of monetary and fiscal policies (euro crisis, fiscal rules, sovereign debt crisis); understanding the importance of reforms to complete the monetary union.
Learning of an analytical and quantitative approach for economic analysis so to strengthen what already learned during the first cycle and be able to apply these tools in an innovative way, also in research contexts.
Knowledge and understanding
To give students familiarity with a broad range of European monetary and fiscal policy issues; to ensure a good knowledge of the economic grounding of the European monetary integration and of the related fragilities; to show students the usefulness of simple analytical models in understanding the relevant aspects of European integration and to give them the ability to apply these analytical tools intelligently.
Applying knowledge and understanding
What is learned can be applied to other situations and to actual work in the context of European institutions and/or national and local public administrations subject to European directives and regulations.
Making judgements
What is learned can be used to assess critically and without prejudices: i) the activity and the decisions of national and European policymakers; ii) the reforms on the agenda. Students will be able to understand novel and complex problems related to the process of economic integration and speculate on future evolutions of the EMU.
Communication skills
Be able to rigorously present facts and complex mechanisms; learn how to present complex facts and economic mechanisms in a comprehensive manner and communicate the relative conclusions, knowledge and rationale to specialists and non-specialized audiences.
Learning skill
The course aims at providing students with the tools necessary for future learning. At the end of the course students are expected to be able to read and understand official documents, scientific articles and databases. Students are also expected to be develop autonomous learning abilities.
Special attention will be given to help students develop their soft skills, such as flexibility, integrity and work ethic, positive attitude, responsibility, teamwork and interpersonal skills.
Teaching method
Online lectures, but students will be asked to participate actively. During the course I will sometimes use Matlab to show some stylized facts. Simple codes will be provided for replication.
Exams
Written and oral examination on all programme. Different rules apply whether the exam will be held in presence or in remote. See the exam rules page or Presentation #0. Teams link for exams.
Grading Policy
Please note that a grade of 30/30 represents achievement that is outstanding relative to the level necessary to meet course requirements (students must show an excellent knowledge of the subject, all written work must be well written, competent and accurate; sloppiness of any kind will prevent a student from getting 30/30 as final grade, no matter if the student feels she/he is well prepared). Bargaining on grading is not allowed. Notice that grading is based on performance rather than effort. If you are not happy with the grade, just improve the performance. It is not possible to submit extra work in the attempt to improve a grade.
Zero tolerance for academic dishonesty
Academic dishonesty includes cheating on exams, plagiarism, improper citation, recycled work, unauthorized assistance, or similar actions. Assignments and projects are specific to individual courses; presenting the same work in two different courses (including previous courses) is considered recycling and is unacceptable.
Students who commit an act of academic dishonesty will receive a failing grade. See also the Exam Rules.
Attedance and Behavior
Syllabus
Last update: 19th October 2020
IMPORTANT: This syllabus will be subject to changes and updates during the course. The final reading list for each topic will be available step by step. In this way I'll be able to tailor the contents of this course to students' needs, interests and background. Please check this syllabus on a regular basis for any updates.
Please notice that
1. Basic Maths and Macroeconomic Tools
- Logarithms, log-linearization, differential equations and difference equations
- Money demand and supply
- Expectations
-
Open Economy Aspects
Final Readings
- Logarithms, log-linearization, differential equations and difference equations
-
Money demand and supply
- Expectations
-
Open Economy Aspects
-
*BW-2019: chapter 13 + Annex on various exchange rate regimes
-
*Presentation #4
-
*Presentation #5
-
Kenneth Rogoff (1996) The Purchasing Power Parity Puzzle, Journal of Economic Literature, Vol. 34, No. 2. pp. 647-668.
-
Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh & Alan M. Taylor (2005). "The Trilemma in History: Tradeoffs Among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility" in The Review of Economics and Statistics, Vol. 87, No. 3, pp. 423--438.
2. Exchange Rates Determinants and the Euro/Dollar Exchange Rate
Final Readings
3. Macroeconomics of Monetary Integration
Final Readings
-
-
*BW-2019: chapter 15
-
*Paul Krugman (2012) "The revenge of optimum currency area", Chapter in NBER book NBER Macroeconomics Annual 2012, Volume 27 (2013).
-
Kenen, P. (1969) "The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View" in R.Mundell and A. Swoboda eds, Monetary Problems of the International Economy, The University of Chicago Press.
-
Mundell, R. (1961) A theory of Optimum Currency Areas, American Economic Review, 51 (4).
4. European Monetary Union - The Transition to the EMU
-
The transition to a monetary union
-
The 5 entry conditions (Maastricht Criteria): Why convergence requirements?
-
How to fix the conversion rates
- Inflation and productivty in a monetary union - the Balassa-Samuelson effect
Final Readings
5. European Monetary Union - Function and Fragilities
Final Readings
-
*Presentations #14 and #15
-
*BW-2019: chapter 16: sections from 16.3* to 16.7*
-
*ECB website contents (see the links in The functioning of the Eurosystem). All the material MUST be covered* (this is summarized in Presentation 14)
-
*DG-2020: chapter 5
-
* The transmission mechanism of monetary policy - The Monetary Policy Committee - Bank of England
6. Fiscal Policy
-
The Government Budget Constraint
-
Fiscal and monetary policy interactions
-
Fiscal policy in a monetary union
-
Fiscal policy externalities
-
Stability and Growth Pact
-
Fiscal Compact
Final Readings
-
*Barry Eichengreen & Charles Wyplosz, 1998. "The Stability Pact: more than a minor nuisance?," Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 13(26), pages 65-113, 04.
-
ECB on the Fiscal Compact see here
-
Thomas J. Sargent & Neil Wallace (1981) Some Unpleasant Monetarist Arithmetic, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review vol. 5, no 3.
-
Buiter, W.H. & Corsetti, G. & Roubini, N., 1992. Excessive Deficits: Sense and Nonsence in the Treaty of Maastricht, available here.
-
M. Wickens (2008), Macroeconomic Theory, Princenton University Press, chapter 5.
6. Eurozone Crisis
- Bubbles
-
The subprimes follies and the great recession
-
Sovreign Debt Crisis
-
Managing the Crisis and the EMS
-
Lessons from the crisis: How to complete the monetary union and conditions for the survival of the Euro
Final Readings
-
*Presentations #18-22
-
*BW-2019: chapter 19
-
*DG-2020: chapter 7
-
*Barry Eichengreen, Charles Wyplosz, (2016) Minimal conditions for the survival of the euro
- *Paul De Grauwe, Yuemei Ji, Fiscal implications of the ECB's bond-buying programme, 14 June 2013, VoxEU.
-
Barry Eichengreen (2008), Sui generis EMU, European Economy, Economic Papers 303, February 2008.
-
Charles Wyplosz, (2006). "European Monetary Union: the dark sides of a major success," Economic Policy, CEPR & CES & MSH, vol. 21(46), pages 207-261, 04
7. Current and future prospects
- Black Swan scenarios
- Current and future challenges
Final Readings
Books
-
BW-2019: Baldwin, Richard and Wyplosz, Charles (2019), The Economics of European Integration, 6th edition, McGraw Hill. This book represents an ESSENTIAL READING for this course.
-
DG-2020: De Grauwe Paul (2020), The Economics of Monetary Union, 13th edition, Oxford University Press. This book represents an ESSENTIAL READING for this course.
- BAG-2017: Blanchard, O., Amighini A., Giavazzi F., (2017), Macroeconomics, A European Perspective, 3rd edition, Pearson.



 Prof.ssa Lucia Leonelli
Prof.ssa Lucia Leonelli