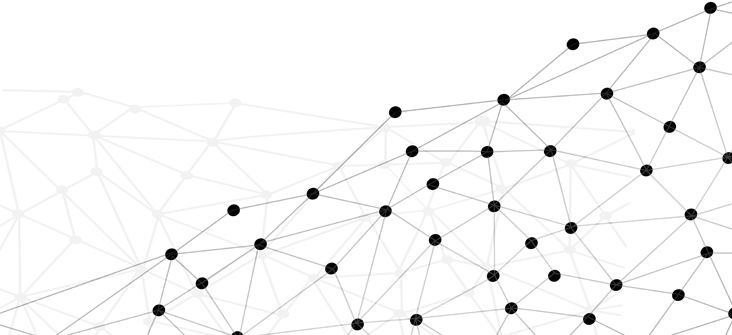EN
IT
Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si propone di introdurre gli studenti/le studentesse alle principali tematiche dell’economia e della finanza pubblica, con riferimento all’analisi delle motivazioni e degli strumenti dell’intervento pubblico nel sistema economico. Il corso è articolato nelle seguenti macro-tematiche:
- Analisi positiva e normativa. Le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia
- Beni pubblici e esternalità
- Teoria delle scelte collettive
- Federalismo fiscale
- Istruzione
- Assicurazione sociale e redistribuzione: il sistema sanitario, pensionistico e assistenziale
- Teoria della tassazione e applicazioni
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Al termine del corso gli studenti/le studentesse saranno in grado di conoscere le motivazioni, le principali attività e le modalità di intervento del settore pubblico all’interno del sistema economico.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
L’utilizzo congiunto di analisi teorica e riferimenti a casi reali consentirà agli studenti/alle studentesse di applicare le teorie e le conoscenze apprese durante il corso per comprendere il funzionamento del settore pubblico nel mondo reale. La capacità acquisita di comprendere le motivazioni e gli effetti delle politiche pubbliche consentirà agli studenti/al
le studentesse di gestire le stesse in ambito nazionale e internazionale.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Le competenze sviluppate durante il corso consentiranno agli studenti/alle studentesse di analizzare autonomamente i diversi strumenti e obiettivi delle politiche pubbliche in ambito economico e di utilizzare gli strumenti dell'analisi economica per interpretare e valutare l’evidenza osservata sull’operare del settore pubblico in diversi contesti.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Le competenze apprese consentiranno agli studenti/alle studentesse di valutare e di saper comunicare l’impatto in termini di efficienza e di equità delle politiche economiche adottate dai diversi governi, in modo rigoroso e formalizzato. Saranno inoltre in grado di comprendere e discutere i rapporti di policy elaborati da istituzioni economiche nazionali e internazionali di fronte a un audience di esperti e non.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Tramite lo studio degli strumenti delle politiche pubbliche in ambito economico e gli approfondimenti su tematiche specifiche proposte durante il corso, lo studente/la studentessa acquisirà la capacità di analizzare in autonomia e, in caso, contribuire alla gestione delle politiche pubbliche in ambito nazionale e internazionale.
Learning Objectives
LEARNING OUTCOMES :
The course aims to introduce students to the economic analysis of the justification for, the scope, and the instruments of public intervention. The course includes the following issues:
1) Positive and normative analysis. Motivations of public intervention in the economic system
2) Public goods and externalities
3) Political economy
4) State and Local Government Expenditures
5) Education
6) Social security and redistribution
7) Taxation in theory and practice
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will know the main motivations justifying public policies and the main instruments and actions the public sector can take to intervene in the economic system.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The joint use of theoretical analysis and empirical cases will allow students to be able to apply skills and knowledge developed during the course to understand the functioning of the public sector in the real world. Understanding the reasons and effects of public policies will enable students to use these policies in national and international institutions.
MAKING JUDGEMENTS
Concepts and methods learned during the course will allow students to critically and constructively assess the different instruments and goals of public policies in the economic system. Students will be able to apply the instruments of economic analysis to interpret and evaluate the empirical evidence and the adequacy of policy solutions in different contexts.
COMMUNICATION SKILLS:
The course will allow students to be able to evaluate and communicate the impact of public policies in terms of their efficiency and equity formally and rigorously. They will also be able to understand and discuss the reports realized by national and international policy institutions with expert and non-expert audiences.
LEARNING SKILLS:
With the knowledge of the main instruments of public policies and the detailed analysis of specific issues put forward during the course, students will be able to analyze autonomously and contribute to the management of public policies in the national and international policy arena.
MARIANGELA ZOLI
Prerequisiti
Microeconomia e Macroeconomia
Prerequisites
Microeconomics and Macroeconomics
Programma
Il corso si articola su tematiche da svolgere in 6 settimane.
Settimana 1: Oggetto e strumenti dello studio dell’economia pubblica: gli strumenti dell’analisi positiva e gli strumenti dell’analisi normativa. Le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia. Esternalità
Settimana 2: Beni pubblici. Political economy.
Settimana 3: Spesa dello Stato e dei livelli inferiori di governo. Istruzione. Assicurazione sociale.
Settimana 4: Sanità. Distribuzione del reddito e programmi di assistenza
Settimana 5: Teoria della tassazione: Incidenza fiscale; Inefficienze.
Settimana 6: La tassazione in pratica: Imposta sul reddito delle persone fisiche, Imposte sulle Società e Imposte indirette.
Program
The course is developed in six weeks.
Week 1: Object and instruments of public economics: positive and normative analysis. The motivations of public intervention in the economic system. Externalities.
Week 2: Public goods. Political Economy
Week 3: State and Local Government Expenditures. Education. Social Insurance.
Week 4: Health Insurance; Income Distribution and Welfare Programs
Week 5: The Theory of Taxation: Tax Incidence; Inefficiencies
Week 6: Taxation in Practice: Personal Income Tax, Corporate Taxation; Indirect taxes.
Testi Adottati
Testi di riferimento:
- Rosen e Gayer (2014), Scienza delle finanze, IV edizione. McGraw Hill.
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Slides del corso e altro materiale disponibile nella classe Teams del corso (se resa disponibile dall’Ateneo) oppure, se questo non fosse possibile, sulla pagina web del corso (protetto da password, che sarà comunicata in classe)
Books
Textbooks:
- Rosen e Gayer (2023), Scienza delle finanze, VI edizione. McGraw Hill
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Course slides and other material will be made available in the Teams classroom (if created by the University) or, alternatively, where not available, on the course webpage (password protected, which will be communicated in class).
Bibliografia
Testi di riferimento:
- Rosen e Gayer (2014), Scienza delle finanze, IV edizione. McGraw Hill
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Slides del corso e altro materiale disponibile nella classe Teams del corso (se resa disponibile dall’Ateneo) oppure, se questo non fosse possibile, sulla pagina web del corso (protetto da password, che sarà comunicata in classe)
Bibliography
Textbooks:
- Rosen e Gayer (2023), Scienza delle finanze, VI edizione. McGraw Hill
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Course slides and other material will be made available in the Teams classroom (if created by the University) or, alternatively, where not available, on the course webpage (password protected, which will be communicated in class).
Modalità di svolgimento
Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali. Gli studenti/le studentesse sono incoraggiati a partecipare attivamente alle lezioni, interagendo con la docente e con i compagni.
Teaching methods
The course is based on lectures. Students are encouraged to actively participate in the lectures, interacting with the lecturer and with classmates.
Regolamento Esame
L’esame è scritto ed è composto di 2 parti. La prima parte consiste in un test a scelta multipla. La seconda parte prevede invece la risposta a due domande aperte, a cui lo studente/la studentessa deve rispondere nello spazio massimo indicato nella prova d’esame. Per ottenere la sufficienza è necessario che lo studente/la studentessa raggiunga un punteggio minimo di sufficienza (voto pari o superiore a 18) in ciascuna prova.
Per ciascuna sessione d’esami, gli studenti/le studentesse avranno la possibilità di sostenere la prova scritta SOLO UNA VOLTA (DUE NELLA SESSIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA AL CORSO). Nel caso in cui lo studente/la studentessa si ritiri durante lo svolgimento della prova scritta, o nel caso in cui la prova scritta non sia sufficiente e lo studente/la studentessa sia respinto, NON sarà possibile ripresentarsi ad appelli successivi nella stessa sessione. Questo insegnamento NON prevede lo svolgimento di pre-appelli.
Criteri di valutazione delle domande aperte:
- 12-17: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
- 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
- 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
- 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
- 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
- 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
Valutazione della prova dello studente/della studentessa nelle domande a risposta multipla: sarà effettuata sulla base della numerosità delle risposte corrette/sbagliate/non date, a dimostrazione dell’ampiezza delle conoscenze acquisite.
Exam Rules
The exam is written and is made of 2 parts. The first part is a multiple-choice test. The second part includes two short essays (the number of words will be specified in the test). To pass the exam, students must have a minimum grade (equal to or above 18) on each of the three tests.
For each exam session, students will have the opportunity to take the written test ONLY ONCE. If the student withdraws during the written test, or if the written test is not sufficient and the student fails, it will NOT be possible to re-apply for subsequent exams in the same session. This course does NOT include mid-term exams (esoneri).
Evaluation criteria of the student's test for the open questions:
- 12-17: significant deficiencies and/or inaccuracies in knowledge and understanding of the
topics; limited analysis and synthesis skills; frequent generalizations.
- 18-20: just sufficient knowledge and understanding of the topics with possible
imperfections; Sufficient analytical, synthesis and independent judgment skills.
- 21-23: Knowledge and understanding of routine topics; Correct analysis and synthesis
skills with coherent logical argumentation.
- 24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis
skills with rigorously expressed arguments.
- 27-29: Complete knowledge and understanding of the topics; remarkable analytical and
synthesis skills. Good independent judgment.
o 30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable analytical and synthesis skills and independent judgment. Arguments expressed in an original way.
The evaluation of the student's test in the multiple choice questions is made on the basis of the number of correct/wrong/not given answers, demonstrating the breadth of the knowledge acquired.
Modalità di frequenza
Anche se la partecipazione alle lezioni è facoltativa, è fortemente raccomandata la frequenza.
Attendance Rules
Although optional, attendance is strongly recommended.
MARIANGELA ZOLI
PAOLO PAESANI
PAOLO PAESANI
EN
IT
Obiettivi Formativi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si propone di introdurre gli studenti/le studentesse alle principali tematiche dell’economia e della finanza pubblica, con riferimento all’analisi delle motivazioni e degli strumenti dell’intervento pubblico nel sistema economico. Il corso è articolato nelle seguenti macro-tematiche:
- Analisi positiva e normativa. Le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia
- Beni pubblici e esternalità
- Teoria delle scelte collettive
- Federalismo fiscale
- Istruzione
- Assicurazione sociale e redistribuzione: il sistema sanitario, pensionistico e assistenziale
- Teoria della tassazione e applicazioni
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Al termine del corso gli studenti/le studentesse saranno in grado di conoscere le motivazioni, le principali attività e le modalità di intervento del settore pubblico all’interno del sistema economico.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
L’utilizzo congiunto di analisi teorica e riferimenti a casi reali consentirà agli studenti/alle studentesse di applicare le teorie e le conoscenze apprese durante il corso per comprendere il funzionamento del settore pubblico nel mondo reale. La capacità acquisita di comprendere le motivazioni e gli effetti delle politiche pubbliche consentirà agli studenti/al
le studentesse di gestire le stesse in ambito nazionale e internazionale.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Le competenze sviluppate durante il corso consentiranno agli studenti/alle studentesse di analizzare autonomamente i diversi strumenti e obiettivi delle politiche pubbliche in ambito economico e di utilizzare gli strumenti dell'analisi economica per interpretare e valutare l’evidenza osservata sull’operare del settore pubblico in diversi contesti.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Le competenze apprese consentiranno agli studenti/alle studentesse di valutare e di saper comunicare l’impatto in termini di efficienza e di equità delle politiche economiche adottate dai diversi governi, in modo rigoroso e formalizzato. Saranno inoltre in grado di comprendere e discutere i rapporti di policy elaborati da istituzioni economiche nazionali e internazionali di fronte a un audience di esperti e non.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Tramite lo studio degli strumenti delle politiche pubbliche in ambito economico e gli approfondimenti su tematiche specifiche proposte durante il corso, lo studente/la studentessa acquisirà la capacità di analizzare in autonomia e, in caso, contribuire alla gestione delle politiche pubbliche in ambito nazionale e internazionale.
Learning Objectives
LEARNING OUTCOMES :
The course aims to introduce students to the economic analysis of the justification for, the scope, and the instruments of public intervention. The course includes the following issues:
1) Positive and normative analysis. Motivations of public intervention in the economic system
2) Public goods and externalities
3) Political economy
4) State and Local Government Expenditures
5) Education
6) Social security and redistribution
7) Taxation in theory and practice
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will know the main motivations justifying public policies and the main instruments and actions the public sector can take to intervene in the economic system.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The joint use of theoretical analysis and empirical cases will allow students to be able to apply skills and knowledge developed during the course to understand the functioning of the public sector in the real world. Understanding the reasons and effects of public policies will enable students to use these policies in national and international institutions.
MAKING JUDGEMENTS
Concepts and methods learned during the course will allow students to critically and constructively assess the different instruments and goals of public policies in the economic system. Students will be able to apply the instruments of economic analysis to interpret and evaluate the empirical evidence and the adequacy of policy solutions in different contexts.
COMMUNICATION SKILLS:
The course will allow students to be able to evaluate and communicate the impact of public policies in terms of their efficiency and equity formally and rigorously. They will also be able to understand and discuss the reports realized by national and international policy institutions with expert and non-expert audiences.
LEARNING SKILLS:
With the knowledge of the main instruments of public policies and the detailed analysis of specific issues put forward during the course, students will be able to analyze autonomously and contribute to the management of public policies in the national and international policy arena.
MARIANGELA ZOLI
Prerequisiti
Microeconomia e Macroeconomia
Prerequisites
Microeconomics and Macroeconomics
Programma
Il corso si articola su tematiche da svolgere in 6 settimane.
Settimana 1: Oggetto e strumenti dello studio dell’economia pubblica: gli strumenti dell’analisi positiva e gli strumenti dell’analisi normativa. Le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia. Esternalità
Settimana 2: Beni pubblici. Political economy.
Settimana 3: Spesa dello Stato e dei livelli inferiori di governo. Istruzione. Assicurazione sociale.
Settimana 4: Sanità. Distribuzione del reddito e programmi di assistenza
Settimana 5: Teoria della tassazione: Incidenza fiscale; Inefficienze.
Settimana 6: La tassazione in pratica: Imposta sul reddito delle persone fisiche, Imposte sulle Società e Imposte indirette.
Program
The course is developed in six weeks.
Week 1: Object and instruments of public economics: positive and normative analysis. The motivations of public intervention in the economic system. Externalities.
Week 2: Public goods. Political Economy
Week 3: State and Local Government Expenditures. Education. Social Insurance.
Week 4: Health Insurance; Income Distribution and Welfare Programs
Week 5: The Theory of Taxation: Tax Incidence; Inefficiencies
Week 6: Taxation in Practice: Personal Income Tax, Corporate Taxation; Indirect taxes.
Testi Adottati
Testi di riferimento:
- Gruber, J. (2023), Scienza delle finanze. Seconda edizione. Egea. Dal Capitolo 1 al Capitolo 15.
Per alcuni argomenti, le slides saranno integrate con riferimenti ai seguenti testi:
- Rosen e Gayer (2014), Scienza delle finanze, IV edizione. McGraw Hill.
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Slides del corso e altro materiale disponibile nella classe Teams del corso (se resa disponibile dall’Ateneo) oppure, se questo non fosse possibile, sulla pagina web del corso (protetto da password, che sarà comunicata in classe)
Books
Textbooks:
- Gruber, J. (2023), Scienza delle finanze. Seconda edizione. Egea. From Chapter 1 to Chapter 15.
For some issues, additional readings may be proposed from the following textbooks:
- Rosen e Gayer (2023), Scienza delle finanze, VI edizione. McGraw Hill
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Course slides and other material will be made available in the Teams classroom (if created by the University) or, alternatively, where not available, on the course webpage (password protected, which will be communicated in class).
Bibliografia
Testi di riferimento:
- Gruber, J. (2023), Scienza delle finanze. Seconda edizione. Egea. Dal Capitolo 1 al Capitolo 15.
Per alcuni argomenti possono essere previste integrazioni dal testo:
- Rosen e Gayer (2014), Scienza delle finanze, IV edizione. McGraw Hill
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Slides del corso e altro materiale disponibile nella classe Teams del corso (se resa disponibile dall’Ateneo) oppure, se questo non fosse possibile, sulla pagina web del corso (protetto da password, che sarà comunicata in classe)
Bibliography
Textbooks:
- Gruber, J. (2023), Scienza delle finanze. Seconda edizione. Egea. From Chapter 1 to Chapter 15.
For some issues, additional readings may be proposed from:
- Rosen e Gayer (2023), Scienza delle finanze, VI edizione. McGraw Hill
- Hindricks and Myles (2006), Intermediate Public Economics, Second edition, the MIT Press
Course slides and other material will be made available in the Teams classroom (if created by the University) or, alternatively, where not available, on the course webpage (password protected, which will be communicated in class).
Modalità di svolgimento
Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali. Gli studenti/le studentesse sono incoraggiati a partecipare attivamente alle lezioni, interagendo con la docente e con i compagni.
Teaching methods
The course is based on lectures. Students are encouraged to actively participate in the lectures, interacting with the lecturer and with classmates.
Regolamento Esame
L’esame è scritto ed è composto di 2 parti. La prima parte consiste in un test a scelta multipla. La seconda parte prevede invece la risposta a due domande aperte, a cui lo studente/la studentessa deve rispondere nello spazio massimo indicato nella prova d’esame. Per ottenere la sufficienza è necessario che lo studente/la studentessa raggiunga un punteggio minimo di sufficienza (voto pari o superiore a 18) in ciascuna prova.
Per ciascuna sessione d’esami, gli studenti/le studentesse avranno la possibilità di sostenere la prova scritta SOLO UNA VOLTA (DUE NELLA SESSIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA AL CORSO). Nel caso in cui lo studente/la studentessa si ritiri durante lo svolgimento della prova scritta, o nel caso in cui la prova scritta non sia sufficiente e lo studente/la studentessa sia respinto, NON sarà possibile ripresentarsi ad appelli successivi nella stessa sessione. Questo insegnamento NON prevede lo svolgimento di pre-appelli.
Criteri di valutazione delle domande aperte:
- 12-17: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
- 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
- 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
- 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
- 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
- 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
Valutazione della prova dello studente/della studentessa nelle domande a risposta multipla: sarà effettuata sulla base della numerosità delle risposte corrette/sbagliate/non date, a dimostrazione dell’ampiezza delle conoscenze acquisite.
Exam Rules
The exam is written and is made of 2 parts. The first part is a multiple-choice test. The second part includes two short essays (the number of words will be specified in the test). To pass the exam, students must have a minimum grade (equal to or above 18) on each of the three tests.
For each exam session, students will have the opportunity to take the written test ONLY ONCE. If the student withdraws during the written test, or if the written test is not sufficient and the student fails, it will NOT be possible to re-apply for subsequent exams in the same session. This course does NOT include mid-term exams (esoneri).
Evaluation criteria of the student's test for the open questions:
- 12-17: significant deficiencies and/or inaccuracies in knowledge and understanding of the
topics; limited analysis and synthesis skills; frequent generalizations.
- 18-20: just sufficient knowledge and understanding of the topics with possible
imperfections; Sufficient analytical, synthesis and independent judgment skills.
- 21-23: Knowledge and understanding of routine topics; Correct analysis and synthesis
skills with coherent logical argumentation.
- 24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis
skills with rigorously expressed arguments.
- 27-29: Complete knowledge and understanding of the topics; remarkable analytical and
synthesis skills. Good independent judgment.
o 30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable
analytical and synthesis skills and independent judgment. Arguments expressed in an
original way.
The evaluation of the student's test in the multiple choice questions is made on the basis of the number of correct/wrong/not given answers, demonstrating the breadth of the knowledge acquired.
Modalità di frequenza
Anche se la partecipazione alle lezioni è facoltativa, è fortemente raccomandata la frequenza
Attendance Rules
Although optional, attendance is strongly recommended.
MARIANGELA ZOLI
PAOLO PAESANI
Prerequisiti
Una conoscenza delle nozioni di base in materia di economia politica può agevolare l'acquisizione dei contenuti del corso. Non sono previste propedeuticità.
Prerequisites
Familiarity with the fundamentals of political economy may facilitate the achievement of the learning objectives. There are no prerequisites.
Programma
Il programma del corso è suddiviso in sei parti come di seguito indicato
1) Le origini dell’'economia politica fra protezionismo e libero scambio: mercantilismo e fisiocrazia
2) L’economia classica, le teorie del sovrappiù, dibattiti su valore e distribuzione: Smith, Ricardo, Malthus, Say, Marx.
3) Dai classici al marginalismo: John Stuart Mill
4) Il marginalismo e l’economia neoclassica: La scuola di Losanna, Marshall e il marginalismo inglese, scuola austriaca e Schumpeter
5) L’economia di Keynes e dei Keynesiani: fallimenti del mercato e intervento pubblico nell'economia
6) L’economia del secondo novecento: sintesi neoclassica del pensiero keynesiano, Sraffa, economia post-keynesiana, liberalismo – ordoliberalismo sviluppi recenti.
La corrispondenza fra parti del programma, concetti chiave di ogni lezione e settimane di insegnamento è la seguente
SETTIMANA 1
Lezione 1: Introduzione e mercantilismo [protezionismo e politica di potenza, colbertismo]
Lezione 2: La fisiocrazia [ordine naturale, circolazione delle merci e della moneta, laissez faire]
Lezione 3: Adam Smith e la Teoria dei sentimenti morali [illuminismo scozzese, morale della simpatia, l'uomo come animale sociale]
SETTIMANA 2
Lezione 4: Adam Smith e la Ricchezza delle Nazioni [divisione del lavoro, accumulazione, mano invisibile]
Lezione 5: Malthus, Say, Bentham [legge della popolazione, legge di Say, utilitarismo]
Lezione 6: David Ricardo [teoria della distribuzione, valore lavoro, vantaggi comparati]
SETTIMANA 3
Lezione 7: Marx [capitalismo, sfruttamento,conflitti]
Lezione 8: Dai classici al marginalismo [utilitarismo multidimensionale, leggi della domanda]
Lezione 9: da Cournot alla scuola di Losanna [matematizzazione dell'economia, equilibrio economico generale, miglioramento e ottimo paretiano]
SETTIMANA 4
Lezione 10: Jevons [scarsità delle risorse naturali, utilità marginale decrescente, ragionamento al margine]
Lezione11: Marshall [l'economia equilibrio parziale, rendimenti crescenti e concorrenza, la dimensione temporale delle scelte economiche]
Lezione 12: Il marginalismo inglese dopo Marshall [economia del benessere, fallimenti del mercato, concorrenza monopolistica]
SETTIMANA 5
Lezione 13: Keynes dal Tract al Treatise [l'instabilità dei prezzi come problema economico, la fine del laissez faire, teoria quantittativa della moneta]
Lezione 14: Keynes e la Teoria generale [domanda effettiva, incertezza, preferenza per la liquidità]
Lezione 15: Scuola austriaca e Schumpeter [innovazione, distruzione creatrice, ciclo e sviluppo economico]
SETTIMANA 6
Lezione 16: La macroeconomia dopo Keynes [sintesi neoclassica del pensiero keynesiano, monetarismo, microfondazioni]
Lezione 17: L'età della disgregazione del pensiero economico [post-keynesiani, Sraffa, neoricardiani]
Lezione 18: Liberismo, Neo-liberalismo, ordo-liberalismo e conclusioni del corso [relazioni fra liberismo e liberalismo, Hayek, Washington consensus]
Program
The course programme is divided into six parts as follows:
1) The origins of political economy between protectionism and free trade: mercantilism and physiocracy
2) Classical economics, theories of surplus, debates on value and distribution: Smith, Ricardo, Malthus, Say, Marx
3) From classics to marginalism: John Stuart Mill
4) Marginalism and neoclassical economics: The Lausanne school, Marshall and English marginalism, Austrian school and Schumpeter
5) The economics of Keynes and the Keynesians: market failures and public intervention in the economy
6) The economics of the second half of the 20th century: neoclassical synthesis of Keynesian thought, Sraffa, post-Keynesian economics, liberalism - ordoliberalism recent developments.
The correspondence between programme parts, key concepts of each lesson and teaching weeks is as follows
WEEK 1
Lecture 1: Introduction and mercantilism [protectionism and power politics, colbertism]Lecture 2: Physiocracy [natural order, circulation of goods and currency, laissez faire]Lecture 3: Adam Smith and the Theory of Moral Sentiments [Scottish Enlightenment, sympathy morality, man as a social animal]
WEEK 2
Lecture 4: Adam Smith and the Wealth of Nations [division of labour, accumulation, the invisible hand]
Lecture 5: Malthus, Say, Bentham [population law, Say's law, utilitarianism]
Lecture 6: David Ricardo [distribution theory, labour value, comparative advantage]
WEEK 3
Lecture 7: Marx [capitalism, exploitation, conflict]
Lecture 8: From Classics to Marginalism [multidimensional utilitarianism, laws of demand]
Lecture9: From Cournot to the Lausanne School [mathematisation of economics, general economic equilibrium, improvement and the Paretian optimum]
WEEK 4
Lecture 10: Jevons [natural resource scarcity, diminishing marginal utility, reasoning at the margin]
Lecture 11: Marshall [partial equilibrium economics, increasing returns and competition, the time dimension of economic choices]
Lecture 12: English marginalism after Marshall [welfare economics, market failures, monopolistic competition]
WEEK 5
Lecture 13: Keynes from the Tract to the Treatise [price instability as an economic problem, the end of laissez faire, quantum theory of money]
Lecture 14: Keynes and the General Theory [effective demand, uncertainty, liquidity preference]
Lecture 15: Austrian School and Schumpeter [innovation, creative destruction, economic cycle and development]
WEEK 6
Lecture 16: Macroeconomics after Keynes [neoclassical synthesis of Keynesian thought, monetarism, microfoundations]
Lecture 17: The age of disintegration of economic thought [post-Keynesians, Sraffa, neo-Keynesians]
Lecture 18: Liberalism, Neo-liberalism, ordo-liberalism and course conclusions [relations between liberalism and liberalism, Hayek, Washington consensus]
Testi Adottati
A. Roncaglia (2016) Breve storia del pensiero economico, Laterza, Bari
A. Roncaglia (2019) L'età della disgregazione. Storia del pensiero economico contemporaneo (capitoli scelti), Laterza, Bari
Books
. Roncaglia (2016) Breve storia del pensiero economico, Laterza, Bari
A. Roncaglia (2019) L'età della disgregazione. Storia del pensiero economico contemporaneo (selected chapters), Laterza, Bari
Bibliografia
Hirschman A. (1956 [1998]) «Interpretazioni rivali della società di mercato» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 11-39, Bollati Boringhieri, Torino
Kaldor N. (1956 [1998]) «Teorie alternative della distribuzione» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 105-131, Bollati Boringhieri, Torino
Roncaglia A., Sylos Labini P. (1995) Il Pensiero economico. Temi e protagonisti, Laterza, Bari
Sassu A. (1987) «Mercato», in G. Lughini, M. D’Antonio (a cura di) Dizionario di Economia Politica, vol. 12, pp. 95-161, Bollati Boringhieri, Torino
Altro materiale sarà distribuito a cura del docente durante il corso.
Bibliography
Hirschman A. (1956 [1998]) «Interpretazioni rivali della società di mercato» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 11-39, Bollati Boringhieri, Torino
Kaldor N. (1956 [1998]) «Teorie alternative della distribuzione» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 105-131, Bollati Boringhieri, Torino
Roncaglia A., Sylos Labini P. (1995) Il Pensiero economico. Temi e protagonisti, Laterza, Bari
Sassu A. (1987) «Mercato», in G. Lughini, M. D’Antonio (a cura di) Dizionario di Economia Politica, vol. 12, pp. 95-161, Bollati Boringhieri, Torino
Additional material will be provided by the course instructor
Modalità di svolgimento
Il corso è articolato su 6 settimane. Ogni settimana sono previste tre lezioni frontali della durata di due ore accademiche ciascuna. Durante ogni lezione il docente espone i contenuti previsti con l'ausilio di presentazioni power point e invita gli studenti e le studentesse a una riflessione critica e al dialogo. Variazioni dell'orario sono possibili in relazione a concomitanti impegni istituzionali e didattici del docente. Tali eventuali variazioni saranno comunicate con congruo anticipo alle studentesse e agli studenti.
Teaching methods
The course is spread over six weeks. Each week there are three lectures of two academic hours each. During each lecture the lecturer presents the planned content with the aid of power point presentations and invites students to critical reflection and dialogue. Variations in the timetable are possible in relation to concurrent institutional and teaching commitments of the lecturer. Any such variations will be communicated to students well in advance.
Regolamento Esame
La verifica dell'apprendimento si effettua esclusivamente attraverso una prova finale. Non sono previste prove intermedie o presentazioni da parte degli studenti.
L'obiettivo della prova finale è verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati. In particolare, La prova di esame valuta, la preparazione complessiva dello studente, la capacità di integrazione delle conoscenze delle diverse parti del programma, la consequenzialità del ragionamento, la capacità analitica e la autonomia di giudizio. Inoltre vengono valutate la proprietà di linguaggio e la chiarezza espositiva, in aderenza con i descrittori di Dublino (1. Conoscenza e capacità di comprensione; 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione; 3. Autonomia di giudizio; 4. Capacità di apprendimento; 5: Abilità di comunicazione.
La prova finale consiste in un esame scritto obbligatorio della durata di 1 ora e trenta minuti.
La prova si compone di quattro domande obbligatorie più una domanda bonus.
Tutte le domande prevedono una risposta aperta e hanno pari peso ai fini dell'attribuzione del voto finale.
Ogni domanda è valutata in trentesimi.
Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei punteggi delle singole domande. Punteggio minimo per superare la prova scritta 18 su 30.
Dopo aver corretto gli elaborati, il docente comunica i risultati agli studenti iscritti all'esame attraverso il sistema Delphi.
Superata la prova scritta di valutazione con un punteggio pari o superiore a 18 su 30 e accettata la valutazione, lo studente se lo desidera può discutere i risultati della prova scritta con il docente.
Gli studenti possono sostenere l’'esame in tutte le date disponibili.
Non è previsto alcun salto d'appello.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio inappropriato;
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico;
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e linguaggio appropriato/tecnico
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
Exam Rules
The verification of learning takes place exclusively through a final examination. There are no intermediate tests or presentations by students.
The objective of the final examination is to verify the achievement of the above-mentioned educational objectives. In particular, the examination assesses the student's overall preparation, ability to integrate knowledge of the different parts of the programme, consequentiality of reasoning, analytical ability and autonomy of judgement. In addition, ownership of language and clarity of exposition are assessed, in adherence with the Dublin descriptors (1. Knowledge and understanding; 2. Ability to apply knowledge and understanding; 3.
The final examination consists of a mandatory written examination lasting one hour and three minutes.
The test consists of four mandatory questions plus one bonus question. All questions are open-ended and carry equal weight for the purposes of awarding the final grade. Each question is marked in thirtieths.
The final mark is the arithmetic mean of the individual question scores.
Minimum score for passing the written test 18 out of 30.
After correcting the examination papers, the teacher communicates the results to the students registered for the examination via the Delphi system.
Having passed the written examination with a mark of 18 out of 30 or higher and accepted the assessment, the student may discuss the results of the written examination with the lecturer if he/she so wishes.
Students may take the examination on all available dates. there is no roll-call jump.
The examination will be assessed according to the following criteria:
FAIL: important deficiencies and/or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited ability to analyse and synthesise, frequent generalisations and limited critical and judgemental skills, the topics are set out inconsistently and with inappropriate language;
18-20: Barely sufficient knowledge and understanding of the topics with possible generalisations and imperfections; sufficient capacity for analysis, synthesis and autonomy of judgement, the topics are frequently exposed in an incoherent manner and with inappropriate/technical language;
21-23: Routine knowledge and understanding of topics; ability to analyse and synthesise correctly with sufficiently coherent logical argumentation and appropriate/technical language
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; Good analytical and synthetic skills with arguments expressed in a rigorous manner but with language that is not always appropriate/technical.
27-29: Comprehensive knowledge and understanding of the topics; considerable capacity for analysis and synthesis. Good autonomy of judgement. Arguments presented in a rigorous manner and with appropriate/technical language
30-30L: Excellent level of knowledge and thorough understanding of topics. Excellent analytical and synthetic skills and independent judgement. Arguments expressed in an original manner and with appropriate technical language.
Modalità di frequenza
La frequenza al corso non è obbligatoria ma fortemente consigliata. Il programma e le modalità di accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi indicati sono le stesse per studenti frequentanti e non frequentanti.
Attendance Rules
Attendance at the course is not compulsory but strongly recommended. The syllabus and the methods for assessing the achievement of the stated learning objectives are the same for attending and non-attending students.
PAOLO PAESANI
EN
IT
Prerequisiti
Microeconomia e Macroeconomia
Prerequisites
Microeconomics and Macroeconomics
Programma
Il corso si articola in 6 tematiche:
Tema 1: Oggetto e strumenti dello studio dell’attività finanziaria pubblica: gli strumenti dell’analisi positiva e gli strumenti dell’analisi normativa. Le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia
Tema 2: I fallimenti del mercato e la teoria delle scelte collettive: beni pubblici, esternalità e scelte collettive. La redistribuzione del reddito
Tema3: Analisi costi-benefici
Tema 4: L’analisi economica della tassazione: analisi degli impatti redistributivi della tassazione; problemi di incidenza e di efficienza, analisi delle distorsioni derivanti dall’introduzione della tassazione; il trade off tra equità ed efficienza. Analisi di alcune imposte in Italia
Tema 5: L’analisi economica della spesa pubblica: le spese per il welfare state. Assistenza e sicurezza sociale: analogie e differenze. I programmi assistenziali means-tested. La previdenza: analisi teorica e le principali riforme in Italia. I programmi a sostegno della disoccupazione. La tutela della salute e il sistema sanitario.
Tema 6: Il decentramento fiscale: analisi della letteratura di prima e seconda generazione. Il modello di Oates (con preferenze omogenee ed eterogenee). La teoria dei club. I modelli più recenti.
Program
The course is articulated into six topics.
1: Object and instruments of public economics: positive and normative analysis. The motivations of public intervention in the economic system.
2: Market failures and the public choice theory: public goods, externalities, and collective choices. Income redistribution: poverty and inequality.
3: Cost-benefit analysis
4: The economic theory of taxation: redistributive impacts; efficiency and translation, distortions and welfare losses; trade-off between equity and efficiency.
5: The economic theory of public expenditure: welfare state expenditures. Social security and social assistance. Means testing. Social security: The pension system, theoretical analysis, and the Italian system. Policy to support labor market participation. The health care system.
6: Multigovernment public finance: First and second generation models. Optimal federalism: advantages and disadvantages of decentralization. Property taxes. Intergovernmental grants.
Testi Adottati
Testi di riferimento:
- Rosen e Gayer (2014), Scienza delle finanze, IV edizione. McGraw Hill. I capitolo saranno indicati durante il corso e sulla pagina web del corso.
Slides del corso e altro materiale disponibile sulla pagina web del corso (protetto da password, che sarà comunicata in classe)
Books
Textbooks:
- Rosen e Gayer (2023), Scienza delle finanze, VI edizione. McGraw Hill. The relevant chapters will be communicated during the lectures and on the course website.
Course slides and other material are available on the course webpage (password protected, which will be communicated in class).
Bibliografia
MATERIALE DIDATTICO:
- Rosen e Gayer (2023), Scienza delle finanze, VI edizione. McGraw Hill. I capitoli saranno indicati durante il corso e sulla pagina web del corso.
Slides del corso e altro materiale disponibile sulla pagina web del corso (protetto da password, che sarà comunicata in classe)
Bibliography
TEACHING MATERIALS:
- Rosen e Gayer (2023), Scienza delle finanze, VI edizione. McGraw Hill. The relevant chapters will be communicated during the course and in the course website.
Course slides and other material are available on the course webpage (password protected, which will be communicated in class).
Modalità di svolgimento
Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali. Gli studenti sono incoraggiati a partecipare attivamente alle lezioni, interagendo con la docente e con i compagni durante le presentazioni.
Teaching methods
The course is based on lectures. Students are encouraged to actively participate in the lectures, interacting with the lecturer and with classmates during the presentations.
Regolamento Esame
Per gli studenti frequentanti e non frequentanti:
L’esame è scritto ed è composto di 2 parti. La prima parte consiste in un test a scelta multipla. La seconda parte prevede invece la risposta a due domande aperte, a cui lo studente deve rispondere nello spazio massimo indicato nella prova d’esame. Per ottenere la sufficienza è necessario che lo studente raggiunga un punteggio minimo di sufficienza in ciascuna prova.
Per ciascuna sessione d’esami, gli studenti avranno la possibilità di sostenere la prova scritta SOLO UNA VOLTA (DUE NELLA SESSIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA AL CORSO). Nel caso in cui lo studente si ritiri durante lo svolgimento della prova scritta, o nel caso in cui la prova scritta non sia sufficiente e lo studente sia respinto, NON sarà possibile ripresentarsi ad appelli successivi nella stessa sessione. Questo insegnamento NON prevede lo svolgimento di pre-appelli.
Exam Rules
For both attending and non attending students:
The exam is written and is made of 2 parts. The first part is a multiple choice test. The second part includes two short essays (the number of words will be specified in the test). Students are required to have a minimum grade in each of the three tests in order to pass the exam.
For each exam session, students will have the opportunity to take the written test ONLY ONCE. In the event that the student withdraws during the written test, or in the event that the written test is not sufficient and the student fails, it will NOT be possible to re-apply for subsequent exams in the same session. This course does NOT include mid-term exams (esoneri).
Modalità di frequenza
Anche se la partecipazione alle lezioni è facoltativa, è fortemente raccomandata la frequenza.
Attendance Rules
Although optional, attendance is strongly recommended.
EN
IT
Obiettivi Formativi
Obiettivi formativi:
Il programma di ricerca dell’economia pubblica - alias scienza delle finanze - è incentrato sulla distinzione-relazione tra l’economia degli interessi privati – gli interessi che sono rivali tra gli individui - e l’economia degli interessi pubblici – gli interessi che sono condivisi tra gli appartenenti a una comunità politica in tale loro capacità. Nell’economia commerciale degli interessi privati il mercato - domanda, offerta, prezzo, scambio - incanala le risorse verso il loro soddisfacimento, sia pure imperfettamente. In quella non-commerciale degli interessi pubblici un meccanismo equivalente non esiste. Essi rimangono affidati all’azione economica pubblica dei governi e alla cooperazione volontaria. I temi centrali di questa materia sono (i) l’analisi normativa – efficienza ed equità - dell’allocazione delle risorse nelle aree commerciale e non commerciale, e (ii) l’analisi positiva – effetti e teorie esplicative - dell’azione economica pubblica.
Conoscenze e capacità di comprensione:
Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza dei problemi e dei metodi di analisi fondamentali dell'economia pubblica, con particolare riferimento ai loro aspetti microeconomici, per portare a comprendere le ragioni dell'intervento pubblico nell'economia nei vari ambiti (ad esempio la salvaguardia dell'ambiente, l'istruzione o la redistribuzione del reddito) e gli strumenti che lo Stato può utilizzare per tale intervento. Durante il corso, saranno forniti dati rilevanti per i principali problemi affrontati.
Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione:
Le nozioni, i concetti e i modelli appresi durante il corso consentiranno agli studenti di:
- capire le basi dell'analisi teorica dell'intervento pubblico;
- capire le motivazioni di tale intervento e le modalità con cui "misurarne" l'opportunità
Quindi, ad esempio, gli studenti saranno, al termine del corso, in grado di valutare l'opportunità e la migliore modalità di intervento nel campo dell'inquinamento ambientale, oltre alle conseguenze che tali modalità hanno in termini di incidenza e benessere sociale.
Learning Objectives
Learning outcomes:
The research program in public economics focuses on the distinction between the economics of private interests - that are rival among individuals - and the economics of public interests - that are “shared” in a political community. The market allocates resources towards private interest satisfaction, albeit imperfectly, while no equivalent mechanism exists for public interests. The central themes of this course are (i) normative analysis - efficiency and equity - in the allocation of resources, and (ii) positive analysis - effects and theories - of public economic actions.
Knowledge and understanding:
The course aims to introduce students to the problems and methods of public economics, with particular reference to their microeconomic aspects, in order to understand the reasons for public intervention in the economy in various fields (for example environmental protection, education or income redistribution) and the tools that the State can use for such intervention. During the course, relevant data will be provided with reference to the main problems addressed.
Applying knowledge and understanding:
The concepts and models learned during the course will enable students to:
- understand the basics of the theoretical analysis of public intervention;
- understand the reasons for this intervention and the ways in which to "measure" its opportunity.
Thus, for example, students will be able, at the end of the course, to evaluate the opportunity and the best modality of intervention in the field of environmental pollution, in addition to the consequences that these modalities may have in terms of incidence and social well-being.
MARIANGELA ZOLI
Prerequisiti
Microeconomia e Macroeconomia
Prerequisites
Microeconomics and Macroeconomics
Programma
Il corso si articola in 6 tematiche:
Tema 1: Oggetto e strumenti dello studio dell’attività finanziaria pubblica: gli strumenti dell’analisi positiva e gli strumenti dell’analisi normativa. Le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia
Tema 2: I fallimenti del mercato e la teoria delle scelte collettive: beni pubblici, esternalità e scelte collettive. La redistribuzione del reddito
Tema3: Analisi costi-benefici
Tema 4: L’analisi economica della tassazione: analisi degli impatti redistributivi della tassazione; problemi di incidenza e di efficienza, analisi delle distorsioni derivanti dall’introduzione della tassazione; il trade off tra equità ed efficienza. Analisi di alcune imposte in Italia
Tema 5: L’analisi economica della spesa pubblica: le spese per il welfare state. Assistenza e sicurezza sociale: analogie e differenze. I programmi assistenziali means-tested. La previdenza: analisi teorica e le principali riforme in Italia. I programmi a sostegno della disoccupazione. La tutela della salute e il sistema sanitario.
Tema 6: Il decentramento fiscale: analisi della letteratura di prima e seconda generazione. Il modello di Oates (con preferenze omogenee ed eterogenee). La teoria dei club. I modelli più recenti.
Program
The course is articulated into six topics.
1: Object and instruments of public economics: positive and normative analysis. The motivations of public intervention in the economic system.
2: Market failures and the theory of public choice: public goods, externalities and collective choices. Income redistribution: poverty and inequality.
3: Cost-benefit analysis
4: The economic theory of taxation: redistributive impacts; efficiency and translation, distortions and welfare losses; trade-off between equity and efficiency.
5: The economic theory of public expenditure: welfare state expenditures. Social security and social assistance. Means testing. Social security: The pension system, theoretical analysis and the Italian system. Policy to support labour market participation. The health care system.
6: Multigovernment public finance: First and second generation models. Optimal federalism: advantages and disadvantages of the decentralization. Property taxes. Intergovernmental grants.
Testi Adottati
Testi di riferimento:
- Rosen e Gayer (2014), Scienza delle finanze, IV edizione. McGraw Hill. I capitolo saranno indicati durante il corso e sulla pagina web del corso.
Slides del corso e altro materiale disponibile sulla pagina web del corso (protetto da password, che sarà comunicata in classe)
Books
Textbooks:
- Rosen e Gayer (2014), Scienza delle finanze, IV edizione. McGraw Hill. The relevant chapters will be communicated during the course and in the course website.
Course slides and other material available on the course webpage (password protected, which will be communicated in class).
Modalità di svolgimento
Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali. Gli studenti sono incoraggiati a partecipare attivamente alle lezioni, interagendo con la docente e con i compagni durante le presentazioni.
Teaching methods
The course is based on lectures. Students are encouraged to actively participate in the lectures, interacting with the lecturer and with classmates during the presentations.
Regolamento Esame
Per gli studenti frequentanti e non frequentanti:
L’esame è scritto ed è composto di 2 parti. La prima parte consiste in un test a scelta multipla. La seconda parte prevede invece la risposta a due domande aperte, a cui lo studente deve rispondere nello spazio massimo di 1 pagina e mezzo. Per ottenere la sufficienza è necessario che lo studente raggiunga un punteggio minimo di sufficienza in ciascuna prova.
Per ciascuna sessione d’esami, gli studenti avranno la possibilità di sostenere la prova scritta SOLO UNA VOLTA (DUE NELLA SESSIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA AL CORSO). Nel caso in cui lo studente si ritiri durante lo svolgimento della prova scritta, o nel caso in cui la prova scritta non sia sufficiente e lo studente sia respinto, NON sarà possibile ripresentarsi ad appelli successivi nella stessa sessione. Questo insegnamento NON prevede lo svolgimenti di pre-appelli.
Exam Rules
For both attending and non attending students:
The exam is written and is made of 2 parts. The first part is a multiple choice test. The second part includes two short essays (the students can use 1 page and a half at maximum to answer). Students are required to have a minimum grade in each of the three tests in order to pass the exam.
For each exam session, students will have the opportunity to take the written test ONLY ONCE. In the event that the student withdraws during the written test, or in the event that the written test is not sufficient and the student fails, it will NOT be possible to re-apply for subsequent exams in the same session. This course does NOT include mid-term exams (esoneri).
Modalità di frequenza
Anche se la partecipazione alle lezioni è facoltativa, è fortemente raccomandata la frequenza.
Attendance Rules
Although optional, attendance is strongly recommended.
MARIANGELA ZOLI
MARIANGELA ZOLI
MARIANGELA ZOLI
PAOLO PAESANI
Prerequisiti
non sono previste propedeuticità
Prerequisites
No pre-requisites
Programma
Il corso segue l'evoluzione dell'idea di mercato nell'ambito della storia del pensiero economico, dai primi contributi dei mercantilisti e dei fisiocratici agli sviluppi più recenti.
I temi principali trattati sono: Mercantilismo, Fisiocrazia, Smith, Ricardo, Marx, Dall'economia classica al marginalismo, Scuola di Losanna, Marshall, Sviluppi Post-Marshalliani, Keynes, Schumpeter, Cambridge dopo Keynes, Sintesi neoclassica, Liberalismo e neoliberalismo.
Program
The course follows the evolution of the market idea within the history of economic thought, from the early contributions of the mercantilists and physiocrats to more recent developments. T
he main topics covered are: Mercantilism, Physiocracy, Smith, Ricardo, Marx, From Classical Economics to Marginalism, Lausanne School, Marshall, Post-Marshallian Developments, Keynes, Schumpeter, Cambridge after Keynes, Neoclassical Synthesis, Liberalism and Neoliberalism.
Testi Adottati
Roncaglia A. (2016) Breve storia del pensiero economico, Bari-Roma: Laterza (Selected Chapters)
Roncaglia A. (2019) L´età della disgregazione: Storia del pensiero economico contemporaneo, Bari-Roma: Laterza (Selected chapters)
Books
Roncaglia A. (2016) Breve storia del pensiero economico, Bari-Roma: Laterza (Selected Chapters)
Roncaglia A. (2019) L´età della disgregazione: Storia del pensiero economico contemporaneo, Bari-Roma: Laterza (Selected chapters)
Bibliografia
Hirschman A. (1956 [1998]) «Interpretazioni rivali della società di mercato» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 11-39, Torino: Bollati Boringhieri
Lunghini, G. (2014) Conflitto crisi incertezza. La teoria economica dominante e le teorie alternative, Torino: Bollati Boringhieri
Dardi M. (1990) «Il mercato nell’analisi economica contemporanea» in G. Becattini (a cura di) Il pensiero economico: temi, problemi e scuole, Torino, UTET
Kaldor N. (1956 [1998]) «Teorie alternative della distribuzione» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 105-131, Bollati Boringhieri, Torino
Materiale aggiuntivo (Slide, articoli).
Bibliography
Hirschman A. (1956 [1998]) «Interpretazioni rivali della società di mercato» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 11-39, Torino: Bollati Boringhieri
Lunghini, G. (2014) Conflitto crisi incertezza. La teoria economica dominante e le teorie alternative, Torino: Bollati Boringhieri
Dardi M. (1990) «Il mercato nell’analisi economica contemporanea» in G. Becattini (a cura di) Il pensiero economico: temi, problemi e scuole, Torino, UTET
Kaldor N. (1956 [1998]) «Teorie alternative della distribuzione» in M.C. Marcuzzo, A. Roncaglia (a cura di) Saggi di Economia Politica, pp. 105-131, Bollati Boringhieri, Torino
Additional material (Slide, articles).
Modalità di svolgimento
Il corso è articolato su 6 settimane. Ogni settimana sono previste tre lezioni della durata di due ore accademiche ciascuna. Variazioni dell'orario sono possibili in relazione a concomitanti impegni istituzionali e didattici del docente.
Teaching methods
The course is divided into 6 weeks. Each week there are three lessons of two academic hours each. Timetable changes are possible due to concomitant institutional and academic commitments of the teacher.
Regolamento Esame
L'obiettivo della prova finale è verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati.
La prova finale consiste in un esame scritto della durata di 1 ora e 30 minuti sull'intero programma (domande aperte).
Gli studenti possono sostenere l’'esame in tutte le date disponibili.
Exam Rules
The objective of the final examination is to verify the achievement of the training objectives outlined above.
The final examination consists of a 90 minutes written examination on the entire programme (open questions).
Students can take the examination on all available dates.
Modalità di frequenza
La frequenza al corso non è obbligatoria ma fortemente consigliata.
Attendance Rules
Class attendance is not mandatory but warmly recommended.
PAOLO PAESANI
PAOLO PAESANI
PAOLO PAESANI



 Prof.ssa Lucia Leonelli
Prof.ssa Lucia Leonelli