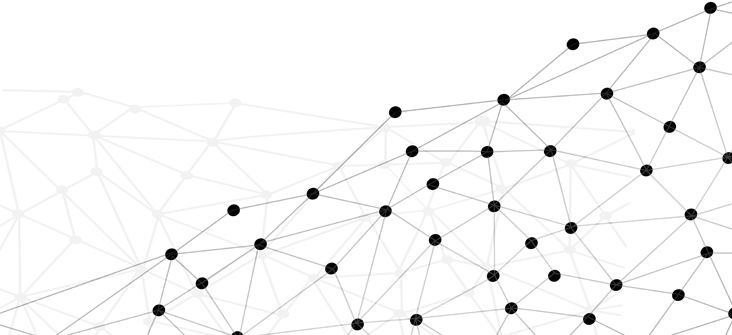EN
IT
Prerequisiti
Nozioni di base di microeconomia, macroeconomia e statistica.
Prerequisites
Basic knowledge of microeconomics, macroeconomics and statistics.
Programma
FOCUS: È giusto che alcuni siano poveri e altri ricchi? La crescita economica è sempre auspicabile? È importante quali beni produciamo e come, non solo quanto e quanti? Lavoriamo troppo? L’'istruzione è un bene finale o un bene intermedio? L’' assistenza sanitaria dovrebbe essere gratuita per tutti? Queste e molte altre domande affondano le loro radici nelle due questioni fondamentali della giustizia economica: cosa determina un buon risultato economico? Come dovrebbero essere distribuiti i benefici e gli oneri della cooperazione economica tra i membri della società? Una domanda preliminare in un mondo globalizzato è: i principi di giustizia devono essere applicati solo a livello nazionale o estendersi a tutta l’'umanità? Il corso presenterà le risposte a queste domande fornite dalle principali teorie contemporanee della giustizia in filosofia politica e alcune implicazioni in termini di politiche economiche.
Il corso sarà diviso in due parti. La prima parte inizierà con l'esposizione dei fondamenti normativi della teoria neoclassica (utilitarismo/assistenzialismo/soddisfazione delle preferenze UWPS). Ci rivolgeremo quindi ad approcci alternativi, che spaziano attraverso lo spettro politico, dal libertarismo alla sinistra/liberalismo all’egualitarismo.
La seconda parte del corso metterà al lavoro le teorie incontrate nella prima parte nel contesto degli odierni dibattiti di politica economica. Vedremo come teorie alternative possano produrre conclusioni politiche molto diverse. Innanzitutto ci concentreremo sull’aumento della disuguaglianza di reddito e ricchezza che molti paesi hanno sperimentato negli ultimi decenni e sulle possibili cause. Considereremo poi costi e benefici dell’ automazione. Venendo alle politiche discuteremo della tassazione sulla ricchezza e sulle successioni, nonché del reddito universale di base, dei servizi universali di base e del capitale universale di base. Passeremo poi alla giustizia ambientale intranazionale e internazionale. Consideremo inoltre l'equità di genere esaminando come politiche, prodotti, servizi e processi abbiano risultati legati al genere.
Infine, in considerazione dell'ampliamento della portata dei mercati nell'organizzazione della società, ci chiediamo: tutto dovrebbe essere in vendita? possiamo avere un’economia di mercato senza diventare una società di mercato?
Il corso incoraggia la partecipazione attiva degli studenti. L'elenco delle questioni da trattare nella seconda parte è provvisorio: potrebbe essere modificato per recepire i suggerimenti degli studenti.
La prima parte del corso, dedicata all’ esame di concetti e teorie generali verra' svolta in 24 ore, la seconda parte dedicata alle applicazioni in ambiti specifici verrà svolta nelle restanti 12 ore
Programma di studio
Preludio: Fatti e valori in economia. Perché non possiamo fare a meno di un punto di vista normativo.
Parte 1. Teorie della giustizia
1. Utilitarismo, soddisfazione delle preferenze: da Jeremy Bentham a Kenneth Arrow e Gerard Debreu.
2. Contrattualismo: John Rawls
3. Libertarismo: Robert Nozick
4. L'approccio delle capacità: Amartya Sen e Martha Nussbaum
5. Parità di risorse: Ronald Dworkin
6. Uguaglianza e comunità: G.A. Cohen
7, Pari opportunità: John Roemer.
8: Critici egualitari della giustizia distributiva: Elisabeth Anderson e Samuel Scheffler.
9 Riconoscimento o redistribuzione?: Axel Honneth, Nancy Fraser e Michael Sandel.
10. Perché no il cosmopolitismo?: Charles Beitz, Seyla Benhabib e Thomas Pogge.
Parte 2. Politiche economiche
1.Disuguaglianza di reddito e di ricchezza: misure e cause.
2.Tassazione dei patrimoni e delle successioni.
3. Reddito di cittadinanza Capitale di base e servizi di base.
4. Giustizia ambientale.
5. Equità di genere.
6. Limiti morali ai mercati.
La prima parte del corso, dedicata all’ esame di concetti e teorie generali verra' svolta in 20 ore, la seconda parte dedicata alle applicazioni in ambiti specifici verrà svolta nelle restanti 16 ore, metà delle quali verranno riservate a presentazioni di articoli o capitoli di libri da parte degli studenti.
Program
FOCUS: Is it just that some are poor and others are rich? Is economic growth always desirable? Is it important what goods we produce and how, not just how much of them? Do we work too much? Is education a final good or an intermediate good? Should health care be free for all? These and many other questions are rooted in the two basic questions of economic justice: What makes for a good economic outcome? How should the benefits and burdens of economic cooperation be distributed among the members of society? A preliminary question in a globalized world is: are principles of justice to be applied only at the national level or extend to all of humanity? Is cosmopolitanism an option? The course ill present the answers to these questions provided by the main contemporary theories of justice in political philosophy and at some of their implications in terms of economic policies. The course will be divided in two parts. The first part will start with an exposition of the normative foundations of neoclassical theory (utilitarianism/welfarism/preferences satisfaction UWPS). We will then turn to alternative approaches, ranging across the political spectrum from libertarianism to left/liberalism to egalitarianism. The second part of the course will put the theories encountered in the first part at work in the context of today's economic policy debates. We will see how alternatives theories may yield very different sets of policy conclusions. First we will focus on the increase in income and wealth inequality many countries have been experiencing in the last decades and on possible causes. We will then consider the costs and benefits of automation and the future of work. Coming to remedies, we will discuss wealth and inheritance taxation as well as basic universal income and basic universal services and basic universal capital. We will then move to environmental justice, defined as the fair treatment of people with respect to environmental policies and then to gender equity by examining how policies, products, services & processes have gendered outcomes. Finally in view of the widening scope of markets in the organization of society we ask: should everything be for sale? can we have a market economy without becoming a market society? The course encourages the active participation of students. The list of issues to be discussed in the second part is provisional: it could be modified to incorporate students' suggestions.
The first part of the course, dedicated to the examination of general concepts and theories, will be carried out in 24 hours, the second part dedicated to applications will be carried out in the remaining 12 hours.
Objectives: By the end of the course, students will have acquired an understanding of the main theories of justice and apply the theories to economic policy issues from inequality and taxation, to trade and migration.Students will be exercised through intensive discussion of topics and the critical appraisal of current research.
Syllabus Prelude: Facts and values in economics. Why we cannot do without a normative point of view. Part 1. Theories of justice 1. Utilitarianism, Welfarism, Preferences Satisfaction: from Jeremy Bentham to Kenneth Arrow and Gerard Debreu. 2. Contractualism: John Rawls 3. Libertarianism: Robert Nozick 4. The Capability Approach: Amartya Sen and Martha Nussbaum 5. Equality of resources: Ronald Dworkin 6. Equality and community: G.A. Cohen 7, Equality of opportunity: John Roemer. 8: Egalitarian Critics of Distributive Justice: Elisabeth Anderson and Samuel Scheffler. 9 Recognition or Redistribution?: Axel Honneth, Nancy Fraser and Michael Sandel. 10. Why not Cosmopolitanism?: Charles Beitz, Seyla Benhabib and Thomas Pogge. Part 2. Policy issues and Controversies 1.Income and Wealth Inequality: measures and causes. 2.Taxation of wealth and inheritances. 3.Basic Income Basic Capital and Basic Services. 4. Environmental Justice. 5. Gender Equity. 6. Moral Limits to Markets. Recommended Texts There is no single text for the course. For the first part of the course some use will be made of Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy by Daniel Hausman, Michael McPherson and Debra Satz, Cambridge Unversity Press 2016 and of Contemporary Political Philosophy by Will Kymlicka Oxford University Press 2002. Another important text is Global Political Philosophy by Matthias Risse, Palgrave- Mc Millan 2016. For the second part readings will also be taken from Inequality by Anthony Atkinson Harvard University Press, 2016, A Brief History of Inequality by Thomas Piketty Belknap Press 2021, The Work of the Future by David Autor, David A. Mindell and Elisabeth B. Reynolds the Mit Press 2022, The Triumph of Injustice by Emmanuel Saez and Gabriel Zucman W.W. Norton, 2019. Other readings: Equality of what? On definitions of equality. E. Anderson: "What is the point of equality?", Ethics, 109, 1999, 287-337. N. Fraser and A.Honneth Redistribution or recognition Verso 2003. J. E. Roemer: Equality of opportunity Harvard University Press 2000. M. Sandel The tyranny of merit. Allen Lane 2020. A. Sen Inequality re-examined, Harvard University Press 1992 On inequality of income and wealth: World Inequality Report 2022 (https://wir2022.wid.world) E. Saez "Public Economics and Inequality: Uncovering our Social Nature" AEA Distinguished lecture, American Economic Association, Papers and Proceedings 2021 111 1-26. E. Saez and G. Zucman "Trends in US Income and Wealth Inequality: Revising After the Revisionists" NBER Working Paper No. 27921, 2020 Comments on updated Smith-Zidar-Zwick wealth share 2022 On Basic Income, Capital and Services I Gough .and J Le Grand (22 January 2021). "The case for Universal Basic Capital: a £10k grant for every 18-year-old". P Van Parijs "The Universal Basic Income: Why Utopian Thinking Matters, and How Sociologists Can Contribute to It. Politics & Society. 2013 41 2 171--182. J Elster "Comment on Van der Veen and Van Parijs" Theory and Society 1986 15 5 709-721 On Environmental Justice P. Mohai, D Pellow, D. and J. T Roberts "Environmental Justice". Annual Review of Environment and Resources 2019 34 . E. A. Page "Distributing the burdens of climate change" Environmental Politics 2008 17 4 556-575. https://doi.org/10.1080/09644010802193419 On Gender Equity Okin, S. Moller. "Introduction: Justice and Gender." Chapter 1 in Justice, Gender, and the Family Basic Books 1991. https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ ?msclkid=7fb88e4eaee311ecaf12e93a28d88a0e On Moral Limits of Markets Sandel M. J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus and Giroux.
Testi Adottati
Non c'è un unico testo per il corso. Per la prima parte saranno usati Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy di Daniel Hausman, Michael McPherson e Debra Satz, Cambridge Unversity Press 2016 e Contemporary Political Philosophy di Will Kymlicka Oxford University Press 2002. Un altro testo importante è World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms 1st Edition di Thomas W. Pogge, Polity 2008. Per la seconda parte verrano tratte letture di Inequality di Anthony Atkinson Harvard University Press, 2016, A Brief History of Inequality di Thomas Piketty Belknap Press 2021, The Work of the Future di David Autor, David A. Mindell and Elisabeth B. Reynolds the Mit Press 2022, The Triumph of Injustice di Emmanuel Saez and Gabriel Zucman W.W. Norton, 2019.
Books
There is no single text for the course. For the first part of the course some use will be made of Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy by Daniel Hausman, Michael McPherson and Debra Satz, Cambridge Unversity Press 2016 and of Contemporary Political Philosophy by Will Kymlicka Oxford University Press 2002. Another important text is World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms 1st Edition by Thomas W. Pogge, Polity 2008. For the second part readings will also be taken from Inequality by Anthony Atkinson Harvard University Press, 2016, A Brief History of Inequality by Thomas Piketty Belknap Press 2021, The Work of the Future by David Autor, David A. Mindell and Elisabeth B. Reynolds the Mit Press 2022, The Triumph of Injustice by Emmanuel Saez and Gabriel Zucman W.W. Norton, 2019.
Bibliografia
Eguaglianza di che? Definizioni e concetti.
E. Anderson: "What is the point of equality?", Ethics, 109, 1999, 287-337.
N. Fraser and A.Honneth Redistribution or recognition Verso 2003.
J. E. Roemer: Equality of opportunity Harvard University Press 2000. M. Sandel The tyranny of merit. Allen Lane 2020.
A. Sen Inequality re-examined, Harvard University Press 1992
Disuguaglianza di reddito e ricchezza
World Inequality Report 2022 (https://wir2022.wid.world) E. Saez "Public Economics and Inequality: Uncovering our Social Nature" AEA Distinguished lecture, American Economic Association, Papers and Proceedings 2021 111 1-26. E. Saez and G. Zucman "Trends in US Income and Wealth Inequality: Revising After the Revisionists" NBER Working Paper No. 27921, 2020 Comments on updated Smith-Zidar-Zwick wealth share 2022
Reddito e Capitale di Base I Gough .and J Le Grand (22 January 2021). "The case for Universal Basic Capital: a £10k grant for every 18-year-old". P Van Parijs "The Universal Basic Income: Why Utopian Thinking Matters, and How Sociologists Can Contribute to It. Politics & Society. 2013 41 2 171--182. J Elster "Comment on Van der Veen and Van Parijs" Theory and Society 1986 15 5 709-721
Giustizia ambientale: P. Mohai, D Pellow, D. and J. T Roberts "Environmental Justice". Annual Review of Environment and Resources 2019 34 . E. A. Page "Distributing the burdens of climate change" Environmental Politics 2008 17 4 556-575. https://doi.org/10.1080/09644010802193419
Equità di genere Okin, S. Moller. "Introduction: Justice and Gender." Chapter 1 in Justice, Gender, and the Family Basic Books 1991. https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ ?msclkid=7fb88e4eaee311ecaf12e93a28d88a0e
Limiti Morali al Mercato
Sandel M. J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus and Giroux. Note delle lezioni e ulteriori letture verranno rese disponibili durante il corso.
Bibliography
Other readings: Equality of what? On definitions of equality.
E. Anderson: "What is the point of equality?", Ethics, 109, 1999, 287-337. N. Fraser and A.Honneth Redistribution or recognition Verso 2003. J. E. Roemer: Equality of opportunity Harvard University Press 2000. M. Sandel The tyranny of merit. Allen Lane 2020. A. Sen Inequality re-examined, Harvard University Press 1992
On inequality of income and wealth: World Inequality Report 2022 (https://wir2022.wid.world) E. Saez "Public Economics and Inequality: Uncovering our Social Nature" AEA Distinguished lecture, American Economic Association, Papers and Proceedings 2021 111 1-26. E. Saez and G. Zucman "Trends in US Income and Wealth Inequality: Revising After the Revisionists" NBER Working Paper No. 27921, 2020 Comments on updated Smith-Zidar-Zwick wealth share 2022
On Basic Income, Capital and Services
Gough .and J Le Grand (22 January 2021). "The case for Universal Basic Capital: a £10k grant for every 18-year-old". P Van Parijs "The Universal Basic Income: Why Utopian Thinking Matters, and How Sociologists Can Contribute to It. Politics & Society. 2013 41 2 171--182. J Elster "Comment on Van der Veen and Van Parijs" Theory and Society 1986 15 5 709-721
On Environmental Justice P. Mohai, D Pellow, D. and J. T Roberts "Environmental Justice". Annual Review of Environment and Resources 2019 34 . E. A. Page "Distributing the burdens of climate change" Environmental Politics 2008 17 4 556-575. https://doi.org/10.1080/09644010802193419
On Gender Equity Okin, S. Moller. "Introduction: Justice and Gender." Chapter 1 in Justice, Gender, and the Family Basic Books 1991. https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ ?msclkid=7fb88e4eaee311ecaf12e93a28d88a0e On Moral Limits of Markets Sandel M. J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus and Giroux. An extensive set of lecture notes and of other readings will be made available during the course.
Modalità di svolgimento
Metodi d'insegnamento
- Lezioni frontali
- Presentazioni orali capitoli di libri o articoli scientifici da parte degli studenti.
Metodi di apprendimento
- Partecipazione attiva alle lezioni
-Studio dei manuali di riferimento, degli articoli indicati e delle note delle lezioni.
- Raccolta in biblioteca dei materiali per la prova finale.
- Studio approfondito di tali materiali e stesura del testo.
Teaching methods
Teaching methods
- Lectures
- Oral presentations by students of chapters of books or scientific articles to be discussed .
Learning methods
- Active class participation
- Studying the indicated textbooks, handouts and journal articles
- Search for materials in the library and on-line for the final assignment.
- Studying these materials and writing the final assignment.
Regolamento Esame
La prova di esame valuta la preparazione d'insieme dello studente, la capacità di integrazione delle diverse nozioni acquisite, la chiarezza del ragionamento, le capacità analitiche e di ideazione.
Inoltre, vengono valutate la capacità di espressione, in aderenza con i descrittori di Dublino (1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento (learning skills); 5: Abilità di comunicazione (communication skills).
La valutazione dello studente prevede una prova finale consistente nella discussione orale di uno scritto (indicativamente di 10000 caratteri) ad articoli o capitoli di libri, scelti dallo studente in accordo con il docente su temi di pertinenza del corso.
Lo studente dovrà nello scrivere e discutere tale commento dimostrare di aver acquisito conoscenze degli argomenti compresi nel programma e sviluppato capacità di analisi dei temi oggetto dele corso.
Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi. Nella valutazione si terrà conto di aspetti quali la comprensione dei temi trattati, l'utilizzo competente di un linguaggio appropriato, la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva, ecc. Il soddisfacimento di tali aspetti è condizione per il raggiungimento di una valutazione pari a ventisette. I voti superiori a ventisette saranno attribuiti agli studenti le cui prove oltre a soddisfare gli aspetti sopra elencati mostreranno un sovrappiù di ricerca e riflessione sui problemi affrontati nei testi commentati e in generale dal corso.
Criteri dettagliati per la formulazione del giudizio espresso in trentesimi:
o Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni
. o 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
o 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
o 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
o 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
o 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
Exam Rules
The exam evaluates the overall preparation of the student, the ability to integrate the various notions that have been learnt, the reasoning clarity, analytical skills the thought originality of the student.
Furthermore, language abilities are evaluated, in compliance with the Dublin descriptors (1. Knowledge and understanding) 2. Ability to apply knowledge and understanding; 3. Making judgments; 4. Learning skills; 5: Communication skills.
The student's evaluation includes a final assignment consisting of an oral discussion of a text (approximately 10,000 characters) written by the student as a comment to articles or book chapters, chosen by the student in agreement with the teacher on topics relevant to the course. In writing and discussing this comment, students must demonstrate that they have acquired knowledge of the topics included in the program and developed analytical skills on the topics covered by the course. The score of the exam is attributed by means of a mark expressed out of thirty. The evaluation will take into account aspects such as understanding of the topics covered, competent use of appropriate language, ability to summarize, clarity of presentation, etc. Satisfaction of these aspects is a condition for achieving a rating of twenty-seven. Grades above twenty-seven will be attributed to students whose work, in addition to satisfying the aspects listed above, shows a surplus of research and reflection on the problems addressed in the texts commented on and in general during the course.
The examination will be graded according to the following criteria:
Unsuitable: major deficiencies in knowledge, understanding and exposition of topics;
18-20: Knowledge, understanding and exposition of topics, ability to analyze and synthesize: barely sufficient
21-23: Knowledge, understanding and exposition of topics, analysis and synthesis skills: acceptable.
24-26: Knowledge, understanding and exposition of topics, analysis and synthesis skills: fair.
27-29: Knowledge, understanding and exposition of topics, analysis and synthesis skills: good
30-30L: Excellent level of in-depth knowledge and understanding of topics. Excellent analytical and synthesis skills and independent judgment. Excellent expression skills.
Modalità di frequenza
Non obbligatoria ma fortemente consigliata.
Attendance Rules
Not compulsory but strongly recommended.
EN
IT
Obiettivi Formativi
Gli studenti acquisiranno la capacità di individuare i problemi etici e di applicare la teorie normative/etiche nel contesto economico. Gli studenti dovrebbero comprendere la distinzione "positivo"---"normativo" nelle scienze sociali e come anche la scienza positiva sia informata da impegni normativi. Gli studenti dovrebbero acquisire una conoscenza di tre approcci principali alla giustizia economica: utilitarismo, libertarismo ed egualitarismo. Dovrebbero acquisire una comprensione dei principali punti di forza e di debolezza di ciascuno di questi approcci nella valutazione dei risultati economici. Infine, gli studenti dovrebbero essere in grado di applicare le varie teorie a questioni di politica economica, dalla disuguaglianza alla tassazione, al commercio e alla migrazione.
Gli studenti saranno esercitati attraverso un'intensa discussione di argomenti e la valutazione della ricerca attuale.
La gamma di teorie e problemi che verranno presentati agli studenti rafforzerà le loro capacità critiche nel pensare all'economia.
CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti acquisiranno familiarità con un'ampia gamma di teorie e questioni politiche legate alla giustizia economica.
APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
I risultati dell'apprendimento del corso possono essere applicati nel successivo lavoro accademico, nonché nel contesto di istituzioni pubbliche e private, internazionali e/o nazionali
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
I risultati dell'apprendimento del corso possono essere utilizzati per valutare in modo critico ed equilibrato l'organizzazione dell'attività economica, a livello sia micro che macro economico.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti riceveranno una formazione intensiva nell'esporre fatti e teorie in modo chiaro e rigoroso sia a un pubblico specializzato che a un pubblico non specializzato.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti del corso sono ancora in una fase in cui stanno imparando ad imparare. Ci si aspetta che gli studenti siano in grado di comprendere rapporti ufficiali e articoli accademici.
Particolare attenzione sarà prestata allo sviluppo delle qualità personali desiderabili negli studenti come ottimismo, integrità e responsabilità, nonché flessibilità e capacità interpersonali.
OBIETTIVI FORMATIVI: Comprensione dei fenomeni dello sviluppo economico in una prospettica storica e contemporanea. Lo studente apprenderà le principali teorie e metodi di indagine in materia, partendo dai modelli di cambiamento strutturale avanzati a metà del secolo scorso fino all'odierno dibattito sul ruolo delle istituzioni e alla cosiddetta rivoluzione sperimentale nello studio della povertà. Particolare rilievo avranno i temi della povertà e della diseguaglianza, dell'istruzione e della salute, dell'imperfezione dei mercati finanziari, dell'accesso ai mercati internazionali nonchè il ruolo degli degli aiuti allo sviluppo.
Gli studenti si eserciteranno attraverso l'intensa discussione dei vari argomenti e la valutazione critica della ricerca contemporanea.
Lo spettro di modelli teorici ed empirici considerati rafforzerà la familiarità degli studenti con l'approccio quantitativo all'analisi economica.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti apprenderanno un'ampia varietà di teorie e problemi legati allo sviluppo economico; il corso metterà in evidenza l'importanza dell'uso di semplici modelli analitici ed econometrici nella comprensione dei fenomeni della povertà e della crescita.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
I risultati formativi del corso potranno applicarsi nell'attività presso istituzioni Internazionali nazionali o locali, 4 pubbliche o private, che svolgano i propri interventi a favore dello sviluppo economico e in generale dell'integrazione sociale.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
I risultati formativi del corso potranno applicarsi nella valutazione critica ed imparziale delle attività e delle decisioni dei of policymakers nazionali e internazionali nei paesi in via di sviluppo. Gli studenti saranno in grado di confrontarsi con i complessi problemi, alcuni ricorrenti altri inediti relativi ai processi dello sviluppo economico.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti si eserciteranno intensamente nella esposizione chiara e rigorosa di fatti e teorie ad un pubblico sia di specialisti che di non specialisti.
Learning Objectives
Students should achieve a capacity to recognize and engage normative/ethical theory in the context of economic policy debates. Students should understand the "positive"---"normative" distinction in the social sciences, and how even positive science is informed by normative commitments. Students should acquire a knowledge of three main approaches to economic justice ---utilitarianism/welfarism, libertarianism and egalitarianism. They should acquire an understanding of the main strengths and weaknesses of each of these approaches in assessing economic outcomes. Finally, students should be able to apply the various theories to economic policy issues from inequality and taxation, to trade and migration.
Students will be exercised through intensive discussion of topics and the appraisal of current research.
The array of theories and problems students will be presented with will strengthen their critical capacities in thinking about economics.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will become familiar with a broad range of theories and policy issues related to economic justice.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Learning outcomes from the course can be applied in academic work as well as in the context of International institutions and/or national and local public administrations.
MAKING JUDGEMENTS:
Learning outcomes from the course can be used to assess critically and in a balanced way the activity and the decisions of national and international policymakers.
COMMUNICATION SKILLS:
Students will receive intensive training in exposing facts and theories in a clear and rigorous way to both specialized and non-specialized audiences.
LEARNING SKILLS:
Students in the course are still in a phase in which they are learning to learn. Students are expected to be able to understand official reports and academic articles.
Special care will be given to the development of desirable personal qualities in students such as optimism, integrity and responibility as well as flexibility and interpersonal skills.
Prerequisiti
Nozioni di base di microeconomia, macroeconomia e statistica.
Prerequisites
Basic knowledge of microeconomics, macroeconomics and statistics.
Programma
• Focus È giusto che alcuni siano poveri e altri ricchi? La crescita economica è sempre
auspicabile? È importante quali beni produciamo e come, non solo quanto e quanti?
Lavoriamo troppo? L’'istruzione è un bene finale o un bene intermedio? L’' assistenza
sanitaria dovrebbe essere gratuita per tutti? Queste e molte altre domande affondano le
loro radici nelle due questioni fondamentali della giustizia economica: cosa determina un
buon risultato economico? Come dovrebbero essere distribuiti i benefici e gli oneri della
cooperazione economica tra i membri della società? Una domanda preliminare in un
mondo globalizzato è: i principi di giustizia devono essere applicati solo a livello nazionale o
estendersi a tutta l’'umanità? Il corso presenterà le risposte a queste domande fornite dalle
principali teorie contemporanee della giustizia in filosofia politica e alcune implicazioni in
termini di politiche economiche.
Il corso sarà diviso in due parti. La prima parte inizierà con l'esposizione dei fondamenti
normativi della teoria neoclassica (utilitarismo/assistenzialismo/soddisfazione delle
preferenze UWPS). Ci rivolgeremo quindi ad approcci alternativi, che spaziano attraverso
lo spettro politico, dal libertarismo alla sinistra/liberalismo all’egualitarismo.
La seconda parte del corso metterà al lavoro le teorie incontrate nella prima parte nel
contesto degli odierni dibattiti di politica economica. Vedremo come teorie alternative
possano produrre conclusioni politiche molto diverse. Innanzitutto ci concentreremo
sull’aumento della disuguaglianza di reddito e ricchezza che molti paesi hanno sperimentato
negli ultimi decenni e sulle possibili cause. Considereremo poi costi e benefici dell’
automazione. Venendo alle politiche discuteremo della tassazione sulla ricchezza e sulle
successioni, nonché del reddito universale di base, dei servizi universali di base e del
capitale universale di base. Passeremo poi alla giustizia ambientale intranazionale e
internazionale. Consideremo inoltre l'equità di genere esaminando come politiche, prodotti,
servizi e processi abbiano risultati legati al genere.
Infine, in considerazione dell'ampliamento della portata dei mercati nell'organizzazione
della società, ci chiediamo: tutto dovrebbe essere in vendita? possiamo avere un’economia
di mercato senza diventare una società di mercato?
Il corso incoraggia la partecipazione attiva degli studenti. L'elenco delle questioni da
trattare nella seconda parte è provvisorio: potrebbe essere modificato per recepire i
suggerimenti degli studenti.
La prima parte del corso, dedicata all’ esame di concetti e teorie generali verra' svolta in 24
ore, la seconda parte dedicata alle applicazioni in ambiti specifici verrà svolta nelle restanti
12 ore
Programma di studio
Preludio: Fatti e valori in economia. Perché non possiamo fare a meno di un punto di
vista normativo.
Parte 1. Teorie della giustizia
1. Utilitarismo, soddisfazione delle preferenze: da Jeremy Bentham a Kenneth Arrow e
Gerard Debreu.
2. Contrattualismo: John Rawls
3. Libertarismo: Robert Nozick
4. L'approccio delle capacità: Amartya Sen e Martha Nussbaum
5. Parità di risorse: Ronald Dworkin
6. Uguaglianza e comunità: G.A. Cohen
7, Pari opportunità: John Roemer.
8: Critici egualitari della giustizia distributiva: Elisabeth Anderson e Samuel Scheffler.
9 Riconoscimento o redistribuzione?: Axel Honneth, Nancy Fraser e Michael Sandel.
10. Perché no il cosmopolitismo?: Charles Beitz, Seyla Benhabib e Thomas Pogge.
Parte 2. Politiche economiche
1.Disuguaglianza di reddito e di ricchezza: misure e cause.
2.Tassazione dei patrimoni e delle successioni.
3. Reddito di cittadinanza Capitale di base e servizi di base.
4. Giustizia ambientale.
5. Equità di genere.
6. Limiti morali ai mercati.
La prima parte del corso, dedicata all’ esame di concetti e teorie generali verra' svolta in 20
ore, la seconda parte dedicata alle applicazioni in ambiti specifici verrà svolta nelle restanti
16 ore, metà delle quali verranno riservate a presentazioni di articoli o capitoli di libri da
parte degli studenti.
Program
•
Focus Is it just that some are poor and others are rich? Is economic growth always
desirable? Is it important what goods we produce and how, not just how much of them? Do
we work too much? Is education a final good or an intermediate good? Should health care
be free for all? These and many other questions are rooted in the two basic questions of
economic justice: What makes for a good economic outcome? How should the benefits and
burdens of economic cooperation be distributed among the members of society? A
preliminary question in a globalized world is: are principles of justice to be applied only at
the national level or extend to all of humanity? Is cosmopolitanism an option? The course
ill present the answers to these questions provided by the main contemporary theories of
justice in political philosophy and at some of their implications in terms of economic
policies. The course will be divided in two parts. The first part will start with an exposition
of the normative foundations of neoclassical theory (utilitarianism/welfarism/preferences
satisfaction UWPS). We will then turn to alternative approaches, ranging across the
political spectrum from libertarianism to left/liberalism to egalitarianism. The second part
of the course will put the theories encountered in the first part at work in the context of
today's economic policy debates. We will see how alternatives theories may yield very
different sets of policy conclusions. First we will focus on the increase in income and wealth
inequality many countries have been experiencing in the last decades and on possible
causes. We will then consider the costs and benefits of automation and the future of work.
Coming to remedies, we will discuss wealth and inheritance taxation as well as basic
universal income and basic universal services and basic universal capital. We will then
move to environmental justice, defined as the fair treatment of people with respect to
environmental policies and then to gender equity by examining how policies, products,
services & processes have gendered outcomes. Finally in view of the widening scope of
markets in the organization of society we ask: should everything be for sale? can we have a
market economy without becoming a market society? The course encourages the active
participation of students. The list of issues to be discussed in the second part is provisional:
it could be modified to incorporate students' suggestions.
The first part of the course, dedicated to the examination of general concepts and theories,
will be carried out in 24 hours, the second part dedicated to applications will be carried out
in the remaining 12 hours.
•
Objectives . By the end of the course, students will have acquired an understanding of the
main theories of justice and apply the theories to economic policy issues from inequality
and taxation, to trade and migration.Students will be exercised through intensive
discussion of topics and the critical appraisal of current research.
Syllabus Prelude: Facts and values in economics. Why we cannot do without a
normative point of view. Part 1. Theories of justice 1. Utilitarianism, Welfarism,
Preferences Satisfaction: from Jeremy Bentham to Kenneth Arrow and Gerard Debreu. 2.
Contractualism: John Rawls 3. Libertarianism: Robert Nozick 4. The Capability
Approach: Amartya Sen and Martha Nussbaum 5. Equality of resources: Ronald Dworkin
6. Equality and community: G.A. Cohen 7, Equality of opportunity: John Roemer. 8:
Egalitarian Critics of Distributive Justice: Elisabeth Anderson and Samuel Scheffler. 9
Recognition or Redistribution?: Axel Honneth, Nancy Fraser and Michael Sandel. 10.
Why not Cosmopolitanism?: Charles Beitz, Seyla Benhabib and Thomas Pogge. Part 2.
Policy issues and Controversies 1.Income and Wealth Inequality: measures and causes.
2.Taxation of wealth and inheritances. 3.Basic Income Basic Capital and Basic Services.
4. Environmental Justice. 5. Gender Equity. 6. Moral Limits to Markets.
Recommended Texts There is no single text for the course. For the first part of the course
some use will be made of Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy by Daniel
Hausman, Michael McPherson and Debra Satz, Cambridge Unversity Press 2016 and of
Contemporary Political Philosophy by Will Kymlicka Oxford University Press 2002. Another
important text is Global Political Philosophy by Matthias Risse, Palgrave- Mc Millan 2016.
For the second part readings will also be taken from Inequality by Anthony Atkinson
Harvard University Press, 2016, A Brief History of Inequality by Thomas Piketty Belknap
Press 2021, The Work of the Future by David Autor, David A. Mindell and Elisabeth B.
Reynolds the Mit Press 2022, The Triumph of Injustice by Emmanuel Saez and Gabriel
Zucman W.W. Norton, 2019. Other readings: Equality of what? On definitions of
equality. E. Anderson: "What is the point of equality?", Ethics, 109, 1999, 287-337. N.
Fraser and A.Honneth Redistribution or recognition Verso 2003. J. E. Roemer: Equality of
opportunity Harvard University Press 2000. M. Sandel The tyranny of merit. Allen Lane
2020. A. Sen Inequality re-examined, Harvard University Press 1992 On inequality of
income and wealth: World Inequality Report 2022 (https://wir2022.wid.world) E. Saez
"Public Economics and Inequality: Uncovering our Social Nature" AEA Distinguished
lecture, American Economic Association, Papers and Proceedings 2021 111 1-26. E.
Saez and G. Zucman "Trends in US Income and Wealth Inequality: Revising After the
Revisionists" NBER Working Paper No. 27921, 2020 Comments on updated
Smith-Zidar-Zwick wealth share 2022 On Basic Income, Capital and Services I
Gough .and J Le Grand (22 January 2021). "The case for Universal Basic Capital: a £10k
grant for every 18-year-old". P Van Parijs "The Universal Basic Income: Why Utopian
Thinking Matters, and How Sociologists Can Contribute to It. Politics & Society. 2013 41 2
171--182. J Elster "Comment on Van der Veen and Van Parijs" Theory and Society 1986
15 5 709-721 On Environmental Justice P. Mohai, D Pellow, D. and J. T Roberts
"Environmental Justice". Annual Review of Environment and Resources 2019 34 . E. A.
Page "Distributing the burdens of climate change" Environmental Politics 2008 17 4
556-575. https://doi.org/10.1080/09644010802193419 On Gender Equity Okin, S.
Moller. "Introduction: Justice and Gender." Chapter 1 in Justice, Gender, and the Family
Basic Books 1991.
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ ?
msclkid=7fb88e4eaee311ecaf12e93a28d88a0e On Moral Limits of Markets Sandel M.
J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus and Giroux.
Testi Adottati
Non c'è un unico testo per il corso. Per la prima parte saranno usati Economic Analysis,
Moral Philosophy and Public Policy di Daniel Hausman, Michael McPherson e Debra Satz,
Cambridge Unversity Press 2016 e Contemporary Political Philosophy di Will Kymlicka
Oxford University Press 2002. Un altro testo importante è World Poverty and Human
Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms 1st Edition di Thomas W. Pogge, Polity
2008. Per la seconda parte verrano tratte letture di Inequality di Anthony Atkinson
Harvard University Press, 2016, A Brief History of Inequality di Thomas Piketty Belknap
Press 2021, The Work of the Future di David Autor, David A. Mindell and Elisabeth B.
Reynolds the Mit Press 2022, The Triumph of Injustice di Emmanuel Saez and Gabriel
Zucman W.W. Norton, 2019.
Books
There is no single text for the course. For the first part of the course some use will be
made of Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy by Daniel Hausman,
Michael McPherson and Debra Satz, Cambridge Unversity Press 2016 and of
Contemporary Political Philosophy by Will Kymlicka Oxford University Press 2002. Another
important text is World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and
Reforms 1st Edition by Thomas W. Pogge, Polity 2008. For the second part readings will
also be taken from Inequality by Anthony Atkinson Harvard University Press, 2016, A Brief
History of Inequality by Thomas Piketty Belknap Press 2021, The Work of the Future by
David Autor, David A. Mindell and Elisabeth B. Reynolds the Mit Press 2022, The Triumph
of Injustice by Emmanuel Saez and Gabriel Zucman W.W. Norton, 2019.
Bibliografia
Eguaglianza di che? Definizioni e concetti.
E. Anderson: "What is the point of equality?", Ethics, 109, 1999, 287-337.
N. Fraser and A.Honneth Redistribution or recognition Verso 2003.
J. E. Roemer: Equality of opportunity Harvard University Press 2000. M. Sandel The
tyranny of merit. Allen Lane 2020.
A. Sen Inequality re-examined, Harvard University Press 1992
Disuguaglianza di reddito e ricchezza
World Inequality Report 2022 (https://wir2022.wid.world) E. Saez "Public Economics
and Inequality: Uncovering our Social Nature" AEA Distinguished lecture, American
Economic Association, Papers and Proceedings 2021 111 1-26. E. Saez and G. Zucman
"Trends in US Income and Wealth Inequality: Revising After the Revisionists" NBER
Working Paper No. 27921, 2020 Comments on updated Smith-Zidar-Zwick wealth share
2022
Reddito e Capitale di Base I Gough .and J Le Grand (22 January 2021). "The case for
Universal Basic Capital: a £10k grant for every 18-year-old". P Van Parijs "The Universal
Basic Income: Why Utopian Thinking Matters, and How Sociologists Can Contribute to It.
Politics & Society. 2013 41 2 171--182. J Elster "Comment on Van der Veen and Van
Parijs" Theory and Society 1986 15 5 709-721
Giustizia ambientale: P. Mohai, D Pellow, D. and J. T Roberts "Environmental Justice".
Annual Review of Environment and Resources 2019 34 . E. A. Page "Distributing the
burdens of climate change" Environmental Politics 2008 17 4 556-575.
https://doi.org/10.1080/09644010802193419
Equità di genere Okin, S. Moller. "Introduction: Justice and Gender." Chapter 1 in Justice,
Gender, and the Family Basic Books 1991.
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ ?
msclkid=7fb88e4eaee311ecaf12e93a28d88a0e
Limiti Morali al Mercato
Sandel M. J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus
and Giroux. Note delle lezioni e ulteriori letture verranno rese disponibili durante il
corso.
Bibliography
Other readings: Equality of what? On definitions of equality.
E. Anderson: "What is the point of equality?", Ethics, 109, 1999, 287-337. N. Fraser and
A.Honneth Redistribution or recognition Verso 2003. J. E. Roemer: Equality of opportunity
Harvard University Press 2000. M. Sandel The tyranny of merit. Allen Lane 2020. A.
Sen Inequality re-examined, Harvard University Press 1992
On inequality of income and wealth: World Inequality Report 2022
(https://wir2022.wid.world) E. Saez "Public Economics and Inequality: Uncovering our
Social Nature" AEA Distinguished lecture, American Economic Association, Papers and
Proceedings 2021 111 1-26. E. Saez and G. Zucman "Trends in US Income and Wealth
Inequality: Revising After the Revisionists" NBER Working Paper No. 27921, 2020
Comments on updated Smith-Zidar-Zwick wealth share 2022
On Basic Income, Capital and Services
Gough .and J Le Grand (22 January 2021). "The case for Universal Basic Capital: a £10k
grant for every 18-year-old". P Van Parijs "The Universal Basic Income: Why Utopian
Thinking Matters, and How Sociologists Can Contribute to It. Politics & Society. 2013 41 2
171--182. J Elster "Comment on Van der Veen and Van Parijs" Theory and Society 1986
15 5 709-721
On Environmental Justice P. Mohai, D Pellow, D. and J. T Roberts "Environmental
Justice". Annual Review of Environment and Resources 2019 34 . E. A. Page
"Distributing the burdens of climate change" Environmental Politics 2008 17 4 556-575.
https://doi.org/10.1080/09644010802193419
On Gender Equity Okin, S. Moller. "Introduction: Justice and Gender." Chapter 1 in
Justice, Gender, and the Family Basic Books 1991.
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ ?
msclkid=7fb88e4eaee311ecaf12e93a28d88a0e On Moral Limits of Markets Sandel M.
J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus and Giroux.
An extensive set of lecture notes and of other readings will be made available during the
course.
Modalità di svolgimento
Metodi d'insegnamento
- Lezioni frontali
- Presentazioni orali capitoli di libri o articoli scientifici da parte degli studenti.
Metodi di apprendimento
- Partecipazione attiva alle lezioni
-Studio dei manuali di riferimento, degli articoli indicati e delle note delle lezioni.
- Raccolta in biblioteca dei materiali per la prova finale.
- Studio approfondito di tali materiali e stesura del testo.
Teaching methods
Teaching methods
- Lectures
- Oral presentations by students of chapters of books or scientific articles to be
discussed .
Learning methods
- Active class participation
- Studying the indicated textbooks, handouts and journal articles
- Search for materials in the library and on-line for the final assignment.
- Studying these materials and writing the final assignment.
Regolamento Esame
La prova di esame valuta la preparazione d'insieme dello studente, la capacità di
integrazione delle diverse nozioni acquisite, la chiarezza del ragionamento, le capacità
analitiche e di ideazione.
Inoltre, vengono valutate la capacità di espressione, in aderenza con i descrittori di Dublino
(1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di
applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3.
Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento (learning skills);
5: Abilità di comunicazione (communication skills).
La valutazione dello studente prevede una prova finale consistente nella discussione
orale di uno scritto (indicativamente di 10000 caratteri) ad articoli o capitoli di libri, scelti
dallo studente in accordo con il docente su temi di pertinenza del corso.
Lo studente dovrà nello scrivere e discutere tale commento dimostrare di aver acquisito
conoscenze degli argomenti compresi nel programma e sviluppato capacità di analisi dei
temi oggetto dele corso.
Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi.
Nella valutazione si terrà conto di aspetti quali la comprensione dei temi trattati, l'utilizzo
competente di un linguaggio appropriato, la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva, ecc.
Il soddisfacimento di tali aspetti è condizione per il raggiungimento di una valutazione pari
a ventisette. I voti superiori a ventisette saranno attribuiti agli studenti le cui prove oltre a
soddisfare gli aspetti sopra elencati mostreranno un sovrappiù di ricerca e riflessione sui
problemi affrontati nei testi commentati e in generale dal corso.
Criteri dettagliati per la formulazione del giudizio espresso in trentesimi:
o Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione
degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni
. o 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
o 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e
sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
o 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi
e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
o 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di
analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
o 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli
capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo
originale.
Exam Rules
The exam evaluates the overall preparation of the student, the ability to integrate the
various notions that have been learnt, the reasoning clarity, analytical skills the thought
originality of the student.
Furthermore, language abilities are evaluated, in compliance with the Dublin descriptors (1.
Knowledge and understanding) 2. Ability to apply knowledge and understanding; 3. Making
judgments; 4. Learning skills; 5: Communication skills.
The student's evaluation includes a final assignment consisting of an oral discussion of a
text (approximately 10,000 characters) written by the student as a comment to articles or
book chapters, chosen by the student in agreement with the teacher on topics relevant to
the course. In writing and discussing this comment, students must demonstrate that they
have acquired knowledge of the topics included in the program and developed analytical
skills on the topics covered by the course. The score of the exam is attributed by means of
a mark expressed out of thirty. The evaluation will take into account aspects such as
understanding of the topics covered, competent use of appropriate language, ability to
summarize, clarity of presentation, etc. Satisfaction of these aspects is a condition for
achieving a rating of twenty-seven. Grades above twenty-seven will be attributed to
students whose work, in addition to satisfying the aspects listed above, shows a surplus of
research and reflection on the problems addressed in the texts commented on and in
general during the course.
The examination will be graded according to the following criteria:
Unsuitable: major deficiencies in knowledge, understanding and exposition of topics;
18-20: Knowledge, understanding and exposition of topics, ability to analyze and
synthesize: barely sufficient
21-23: Knowledge, understanding and exposition of topics, analysis and synthesis skills:
acceptable.
24-26: Knowledge, understanding and exposition of topics, analysis and synthesis skills:
fair.
27-29: Knowledge, understanding and exposition of topics, analysis and synthesis skills:
good
30-30L: Excellent level of in-depth knowledge and understanding of topics. Excellent
analytical and synthesis skills and independent judgment. Excellent expression skills.
Modalità di frequenza
Non obbligatoria ma fortemente consigliata.
Attendance Rules
Not compulsory but strongly recommended.



 Prof.ssa Lucia Leonelli
Prof.ssa Lucia Leonelli